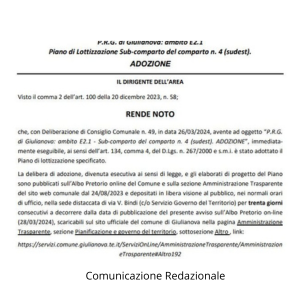Storie fantastiche dal cratere aquilano
FIORI
di Luigi Fiammata
Giovanni sfiorava, con le sue dita grassocce, i petali teneri delle viole del pensiero; guardava ammirato il fiore bianco e succoso della camelia. Come un cartoccio di zucchero filato nel silenzio di una fiera di paese. Giovanni riusciva ad avere colori anche in inverno, sul balcone del suo appartamento, appena protetto dal freddo più stringente, e però capace di raccogliere il sole anche nelle giornate più grigie del gennaio aquilano, con le sue piccole, ingenue, attenzioni. Era il suo piccolo segreto, che avvolgeva nella nebbia delle cose che non raccontava mai a nessuno. Ci passava le ore, sul balcone. Al mattino, quando ancora il sole faceva fatica a sorgere, apriva la finestra del suo piccolo studio di casa e usciva fuori nel gelo sottozero. Imbacuccato con un vecchissimo maglione di lana sferruzzato trent’anni prima dalla mamma, indossato sopra il pigiama e una vestaglia di flanella che arrivava fino ai piedi, coperti da calzerotti lanosi e ciabatte di peluche.
Il fiato sembrava ghiacciarsi in aria e restare sospeso, prima di cadere a terra spezzato in piccoli ghiaccioli come vetrini nel caleidoscopio. E accarezzava gli steli delle piante; rimboccava le coperte che aveva messo a protezione della terra e delle radici, perché non soffrissero troppo l’aria vetrificata. Versava delicato, una mattina sì ed una no, un poco di acqua, mischiata con i fondi del caffè, nei vasi, ed era come portare la colazione a letto ad una donna amata. Quei colori. Azzurro tenue e bruno nero, e bianco, e il giallo degli stami. Accarezzavano gli occhi, prima di alzare lo sguardo lungo la strada, sotto di lui che viveva al quarto piano, e intorno, enormi crateri polverosi e grigi, e secchi, di palazzi appena abbattuti. E gli scheletri vuoti, di quelli ancora da abbattere. Soltanto il suo s’era salvato in quella via. E dopo oltre un anno di riparazioni era rientrato in casa, in tempo per festeggiare, da solo, il Natale del 2010.
Quello sguardo fuori dal balcone, dentro il colore innaturale del cemento nudo, lo riportava, di colpo, al giorno di lavoro che stava per iniziare. Un caffè veloce, un paio di biscotti di crusca che sapeva di tufo, e la doccia sulla sua pancia rotonda, la cravatta, quella che non era ancora macchiata di sugo e salsine varie, e si avviava al bus. Il barcollante autobus arancione, lo portava, da casa, fino all’ufficio appena riaperto, quasi in centro. Come ogni, mattina, prima di timbrare il cartellino, andava a dare uno sguardo alle spalle del palazzo appena ristrutturato. C’era un tubo dell’acqua che usciva da una casa, in zona quasi rossa, che perdeva. Da mesi e mesi. Ora, col gelo, formava una specie di stalagmite ghiacciata, che, dall’asfalto, cercava di abbracciare in alto il muro sconnesso, come un puntellamento naturale, scricchiolante. Era sempre lì. Nessuno si preoccupava di chiudere quel rubinetto.
E poi attraversava la porta a vetri oscurati, passava il badge con la sua faccia calva nell’apposita feritoia magnetica e raggiungeva la sua scrivania loculo, dotata di confortevole computer. Il cui video era guasto da sempre. Emanava una fantasmatica luce verdina. E Giovanni per lavorarci aveva già perso altre due diottrie. Il suo ufficio era l’unico in cui i termosifoni erano guasti, e, per ovviare ai brividi, era sempre acceso un piccolo termosifone elettrico, insufficiente ma rumorosissimo, che gli procurava un mal di testa continuo e lacerante. Ad ogni richiesta di Giovanni, di porre rimedio alla situazione, il suo capo rispondeva invariabilmente che si doveva lavorare comunque, in qualunque condizione.
Il suo capo. Un viscido incrocio tra un lamellibranco e un untuoso sicario della Santa Inquisizione. Un esemplare perfetto di sciacallo scodinzolante sottomissione davanti ai lupi e tirannico nei confronti di ogni suo simile. Aveva preso di mira Giovanni, da sempre. E lo vessava in ogni modo immaginabile da una mente ottenebrata dal colesterolo della sua spocchiosa perfidia. Il capo aveva installato una telecamera nell’ufficio di Giovanni, puntata direttamente sulla sua faccia. Di modo che, ogni volta che si accorgesse di un sorriso di Giovanni, per una qualsiasi ragione, lo chiamava urlando e gli affidava i lavori più improbabili. Come ad esempio recuperare le graffette metalliche da tutti gli uffici del palazzo di tre piani e inventariarle. O come ricopiare in bella copia, a mano, l’intero registro del protocollo corrispondenza, in entrata e in uscita, dal 1975 ad oggi.
Quel mattino, il capo, appena visto Giovanni sedersi al suo posto di lavoro, gli inviò una mail di convocazione immediata al suo cospetto. Certe volte il capo non si degnava di parlare coi suoi sottoposti. Una volta entrato nell’ufficio del capo, Giovanni, non invitato a sedersi, restò in piedi a sorbirsi un terrificante cazziatone oltre i decibel consentiti dalla Convenzione di Ginevra. Era successo che il Ministero, per mezzo dei suoi Ispettori, aveva verificato che tutte le pratiche AB145/k, invece di essere archiviate con il codice 343-326/y, erano state archiviate con il codice 343-326/z. Il capo aveva i capelli dritti, il viso congestionato, e il naso sporco di polvere bianca, mentre lo insultava strillando come il gesso strisciato sulla lavagna, dalla parte dura.
Non era un lavoro di Giovanni, quello. Non gli passavano neanche di mano, quelle pratiche. Quelle pratiche in genere le curava proprio lui, il capo. Soprattutto se riguardavano ragazze giovani; allora il capo le faceva entrare subito nel suo ufficio. Cortesissimo. Se invece riguardavano rumeni ad esempio, li smistava tutti da un altro suo collega. Commentando sempre che era meglio che quella gente se ne tornasse “alle case loro”, e aggiungendo, invariabilmente, col suo sorriso di denti nerofumo, che però lui, il capo, non era certo razzista. Giovanni fu obbligato a restare in ufficio l’intero pomeriggio, e fino la sera alle dieci. Dovette riprendere ognuna di quelle pratiche e cambiare il codice di archiviazione, una per una. Non andò a pranzo. Non aveva più fame, per la cena. Non c’erano straordinari sul suo posto di lavoro; quello era solo il minimo che era tenuto a dare. Tutto, più di tutto. E senza ringraziamenti. Rientrò in casa tardissimo. Era dovuto rientrare a piedi, perché a quell’ora, a L’Aquila, di autobus non ne passano più.
Giovanni si tolse il cappotto, e si guardò nello specchio dell’ingresso. Aveva gli occhi arrossati, ed era pallido. Due lacrime gli scesero dal bordo degli occhi. Scolpirono il suo viso e caddero agli angoli della bocca. E quelle due lacrime gli aprirono una strada di pianto nel cuore. Silenzioso. Come un bicchiere che trabocchi. Provò ad asciugarsi il volto con le dita, ma le lacrime continuavano a scendere. Allora uscì fuori sul suo balconcino. Nella luce dei lampioni lontani i fiori avevano colori d’ombra e porpora. Giovanni sentì una mano forte che gli stringeva il petto. Sempre di più, e gli mancava il respiro. Era come precipitare dentro un sogno d’ovatta, mentre i rumori si cancellavano lentamente, e si sentiva il buio dentro. Da immergersi, dentro quel mare notturno e freddo, senza onde, e l’acqua lo ingoiava, senza lasciarne traccia in superficie.
Giovanni cadde sui vasi dei suoi fiori, il viso sporco di terra fredda. L’alba del mattino dopo era forse ancora più gelida. E sul balcone di Giovanni, però, sembrava primavera. Ciclamini, viole, camelie, piccole margherite e bucaneve. Erano esplosi tutti intorno. Sembravano tiepidi, i petali, e musica le foglie. E i colori erano lampi che aprivano la notte. Un raggio di sole arancio sfiorò il balcone, da est. E il silenzio sembrava meno freddo.