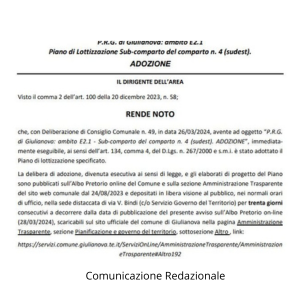a Riccardo
L’AQUILA – Un’alta e nuda parete di roccia calcarea, che cede il suo chiaro oro diurno al rosso acceso dei nitidi tramonti, incendiandosi di un fuoco effimero contro l’azzurro puro del cielo montano. Questo è il Gran Sasso, così come lo contempli dall’Aquila, nei freddi e precoci crepuscoli d’inverno, o nelle serate, placide e raramente torride, delle corte estati. La Grande Montagna irrompe nei vicoli e nelle piazze, quando meno te lo aspetti, imponente e silenziosa, a volte minacciosa, ma sempre vagamente arcana, con la sua perenne tensione verso il cielo. Gli antichi popoli italici narravano leggende su questa grande roccia e sulle sue pendici avevano posto un bosco sacro, affascinati dalla voce del vento e dal canto delle acque che incessanti provengono dalle sue profondità.
L’Aquila nasce, cresce e vive della roccia dorata e rosa della sua montagna, nutrendosi alle acque zampillanti che, prima che, nel ‘200, Federico II le cambiasse il nome, in onore forse all’emblema imperiale, le avevano già imposto un nome. Accula, infatti, si chiamava, luogo delle acque, ed è facile seguire di esse il corso, alla ricerca del messaggio eterno che dall’alto pare riversarsi su chi si dispone all’ascolto: dal cielo alla Montagna, dalla Montagna alla pietra, dalle sorgenti alle fontane.
Arrivando in città dal versante del Gran Sasso, una moderna fontana sembra suggerire una chiave di lettura della città. La Fontana Luminosa si innalza dominando il viale che non a caso si intitola al “Gran Sasso”. Le due donne che vi sono effigiate, quasi come Oreadi, danno le spalle alla Montagna, ma non per affronto, quanto perché designate ad elargire il dono che il cielo invia loro tramite la roccia. Sorreggono assieme una conca, e la inclinano perché l’acqua che a loro è affidata venga di nuovo donata all’oscurità del grembo accogliente di quella stessa terra che, madre di norma tranquilla, deve poi consolare e gestare da capo una città che periodicamente, in pochi istanti, in una subitanea e imprevedibile follia di matrigna crudele, distrugge. Due donne che sembrano le due facce opposte della terra. Eppure i loro volti sono impassibili, perché alla terra sovente non interessa il destino degli uomini. È altrove che questo viene considerato e la montagna ne indica in eterno il luogo.
Dalla Fontana Luminosa l’acqua si nasconde e si divide, dando segni della sua presenza ovunque la pietra la attiri. La Fontana del Nettuno, con il suo antico dio incastonato nelle pietre, pare estranea alla corona dei monti ed è invece presagio di sentieri futuri, ma la piccola fontana che le sta di fronte è un sollievo immediato, con la sua freddissima acqua cristallina all’ombra di floridi tigli. I vicoli del centro accolgono quindi il passo, come un intricato labirinto, una via dell’esistenza su cui si affacciano le dimore degli uomini, e, quando pare che la stanchezza e la sete prendano il sopravvento, una nuova fontana ti aspetta, al centro di una piazza che invita al riposo o ad un crocevia che esige la scelta di una nuova direzione.
Intraprendi il cammino e, improvvisa, una piazza si apre, dominata dalla bianca cortina litea di Santa Maria di Paganica, con i suoi portali, entrate quadrangolari a sancire lo spazio dell’uomo, sovrastati da lune circolari, a rammentare che l’uomo non è solamente nel tempo, ma vive proiettato verso l’eterno. Sali le scale del sagrato come se scalassi le pareti del Gran Sasso, e lo sguardo viene rapito verso l’azzurro del cielo. La fontana canta nella piazza, lì accanto. E ancora riparti nel labirinto e ti pare di aver perso l’orientamento. Ma San Pietro è a pochi passi e i colombi attorniano allegri la fontana al centro della piazza. Ai piedi della chiesa una scalinata e un sagrato, un portale che si apre, fra due antichi leoni, su una navata di quiete e silenzio. San Giorgio combatte il drago nell’abside sinistra, nella penombra attraversata da minuto pulviscolo incendiato dalla luce obliqua del rosone. E l’acqua della fontana disseta, gelida come un colpo di lancia, la dolorosa solitudine dell’anima, spazzando via le crudeli perversità del soffio del drago. L’invito al riposo è esaudito: nuova forza è stata attinta nell’acqua e nel grembo di pietra dell’antica chiesa.
Ma il labirinto esige che le soste siano brevi ed ancora ti ricevono i vicoli vetusti, con nuove fonti che spezzano il cammino. La discesa è interrotta da piazzetta Rivera, con la sua acqua riservata che prepara alla unica fonte cui il tempo ha negato lo scopo. Fontesecco, la chiamano, e d’improvviso la gola pare riarsa e l’udito vuoto e solitario. Attendevi ristoro, ma devi ancora proseguire. Una salita breve allora ti conduce ad una nuova piazza sancita dalla pietra dorata di Santa Maria di Roio, e poi, cercando sollievo alla sete, finalmente incontri una nuova fonte, allegra e canterina, mentre San Marciano apre le sue porte ad una nuova meditazione. Segui ancora l’invisibile filo di Arianna, in questi luoghi intessuto di acqua e pietra, e la grande veduta di Piazza Duomo offre una copiosa scelta al desiderio. Due fontane a forma di uomini paiono sancire al maschile la femminile fecondità dell’acqua, loro trasmessa tramite le lontane donne della fontana di fronte al Gran Sasso. E nella Piazza Grande, sotto le torri gemelle della Cattedrale e all’ombra dell’alcova delle Anime Sante, si accendono colori e profumi di frutti e fiori, splendono i rami e i ferri cesellati, i tessuti e le mercanzie di paesi lontani, e risuona il quotidiano e mattutino vocio del mercato secolare, mentre due piccole ed umili fonti disegnano assieme alle sorelle più grandi una croce d’acqua, che zampilla per saziare la sete degli uomini.
Anche i venti paiono incontrarsi in questo luogo, portando l’incessante eco della voce dei monti, parlando del soffio che vivifica e sorregge, assieme all’acqua che disseta e alla pietra che sostiene. E proprio il vento trascina invisibile verso una meta che il cuore difficilmente può dimenticare. Il vento ti guida, percorrendo prima i vicoli attorno a Santa Giusta, con acqua e pietra che si avvinghiano in amoroso abbraccio, luogo in cui la fontana elargisce il suo limpido tesoro dalla stessa facciata della chiesa, e poi in discesa, lungo i mille ripidi gradini di Costa Masciarelli, dai quali lo sguardo spazia nella grande piana alluvionale dell’Aterno. A breve distanza, fra brume e salici d’argento si nasconde il luogo in cui, sopra i tumuli celati di ben più remoti guerrieri, ancora giace il sogno infranto di un gran condottiero che invano tenne sotto assedio l’indomita città, sperando nuove conquiste e lauti bottini, ottenendo invece una cruenta morte e una imperitura memoria fra gli abitanti da lui vessati. Costa Masciarelli solo per un istante approccia la strada al guerriero intitolata, Via Fortebraccio, come a definire nel vento la brevità delle umane ambizioni, e sorpassa Costa dei Poeti e Costa dei Ciuchi, ironizzando ancora, in puro stile aquilano, sulle pretese virtù degli ingegni dei mortali. La meta è vicina e, prima di arrivarvi, devi sorpassare le mura civiche, prendendo acqua presso una nuova sorgente, in Piazza Bariscianello, che, come una grande conchiglia di San Giacomo, pare vestire della cappa del pellegrino colui che, attraverso Porta Bazzano, lascia le preoccupazioni della città per trovare la via dello spirito.
Una breve salita e Collemaggio ti accoglie con il suo cesello di pietra bianca e rosa, i suoi ampi rosoni di puro merletto, i suoi portali scolpiti nell’armonia del calcare dorato, aperti su tre navi di silenzio. Qui il labirinto diviene manifesto nel pavimento, che cresce di lastre lucidate dai secoli, ancora bianche e rosa, per aprire la via alla Porta Santa, attraverso cui fiorisce il dono del Perdono, e all’ultimo talamo dove riposa colui che rifiutò un Anello, altrimenti benedetto, pur di restare fedele al suo Sposo. Il silenzio qui viene difficilmente rotto dalle frotte di turisti (non ultimi coloro che vi cercano segni e mappe di misteri più o meno plausibili), e pare invece sgorgare dall’antico e solenne organo a canne, stranamente barocco nell’assorto romanico che scivola nelle arcate delle navate. Silenzio e quiete. Pace e ristoro. Nel chiostro adiacente un pozzo si apre nell’oscurità del grembo fecondo di acque.
Ma ancora non puoi arrestare il cammino e devi lasciare il grande prato, sorta di eco edenico, su cui si adagia la grande Basilica. Ripercorri il cammino e, una volta rientrati in città, e devi ora salire per intero la via che ricorda Fortebraccio. Ardua salita la cui vetta è la facciata di pietra bianca di San Bernardino. Puoi sostare ad una fontana prima di ascendere la solenne gradinata, per poi riposare all’ombra della cupola e del campanile, ristorandoti ancora ad una ennesima fonte persa in un fazzoletto di verde ai piedi delle absidi solenni.
Un’ultima tappa (eppure non tutte le novantanove infinite possibili soste hai toccato), prima che ogni filo intrecciato dalle acque sia intessuto nel merletto finale. Pochi passi e una torre apre il suo occhio fatto di ore al terso cielo, guglia di pietra a segno della presenza della Grande Montagna. Colà, nel luogo eletto a simbolo della civitas, la torre, imperterrita testimone di secoli passati, ogni sera lancia al contado i novantanove rintocchi a memoria del dì in cui L’Aquila iniziò adulta il suo volo, verso il cielo terso, oltre la roccia, nutrita di chiare acque e limpido vento. Ma l’acqua ti invita a proseguire e allora devi scendere e scendere, finché non tocchi il limite del pendio, lì dove le mura megalitiche segnalano l’incontro con la valle. Ed ecco, ogni rivolo, ogni sorgente, ogni goccia viene raccolta, cullata e ricamata nei mascheroni – novantanove, si dice, ma se li conti non sono mai tanti, ma di più o di meno, come se ricordassero che è impossibile contare le stille che formano il mare – della Fontana delle Cannelle. Ecco la meta finale, al centro delle melodiose voci delle innumerevoli acque che sgorgano dalla pietra per essere di nuovo donate, dopo aver reso feconda la città che ha preso il loro nome.
Ma le voci, i profumi, la gioia, la vita stessa sono state trafugate dall’oscurità convulsa e polverosa di una notte d’aprile. Ed ora restano solo la pietra, ferita e devastata, e l’acqua, il cui canto silenzioso porta, nonostante tutto, presagi di nuova vita alla città deserta. Perché la vita, la storia, i profumi e le voci della città di pietra sui monti giungano in eredità alla città di cemento sul mare, affidate al Grande Fiume della nostra terra, come i resti miracolosi del vescovo di Amiternum che divenne patrono della obliata Ostia Aterni. Le fresche acque dei monti giungano e si mescolino dolcemente all‘Adriatico selvaggio, persuadendo Pescara la commerciale, la moderna, la dinamica, e con lei l’intero nostro mondo perso nella modernità spersonalizzante, ad accogliere e conservare come prezioso tesoro questa nuova ed assieme antica eredità ricevuta dalla ferita sorella dei monti, la necessità sempre acuta e mai inutile di dissetarsi all’eterna fonte, di saziarsi dell’acqua, del vento, di lasciarsi sostenere dalla roccia come i nostri avi seppero fare. I nostri avi che vissero in questa città perduta fra i monti, quest’Aquila bella che non può morire, e che deve poter di nuovo volare.
Beatrice Sabatini