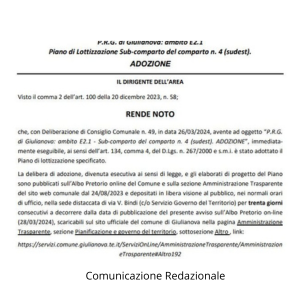Lo stazionamento di musicanti, con strumenti e altoparlanti, nelle piazze e nei larghi, nei vicoli o nei cortili dei caseggiati delle zone a forte densità di popolazione, a Napoli, si chiamava “a pusteggia”. Sull’argomento mi è rimasto a casa un bel libretto della Newton-Compton uscito della collana tascabili a 1000 lire che mi capitò di comprare nella primavera del 1995, quando veniva distribuita in edicola la serie “Napoli Tascabile”. Scritto da Mimmo Liguoro, giornalista RAI, si intitola: “I posteggiatori napoletani”. Così ho scoperto quest’altro significato dei termini “posteggiatore” e “posteggia”.
Fino a quel momento, per me, i posteggiatori erano i guardamacchine dei parcheggi pubblici (tecnicamente: incustoditi), di fatto custoditi da personale “volontario”, i guardamacchine, appunto: posteggiatori che in cambio del servizio chiedevano (e chiedono, ove resistono) un piccolo contributo. Mentre la “posteggia” era stata fin allora – per me e per i miei coetanei accomunati dalla stessa parlata gergale – la pratica del corteggiamento a tecnica stanziale: fare da “palo” restando sempre fermo nello stesso posto, davanti al portone o sotto al balcone della “fortunata” di turno. Ma era anche l’attesa nel luogo per l’incontro, dove impalato si aspettava il solito (o la solita) ritardatario.
Quelli che a Napoli erano chiamati i “posteggiatori” secondo questa nuova accezione, da noi, in provincia, erano chiamati concertini, o cantanti, o musicanti. Qualcuno li nominava anche “straccia-facenn”. Ma credo che la realtà poi, al di là del nome, fosse la stessa, anche se noi, i provinciali, dimostravamo di possedere un lessico meno sofisticato di quelli della città. E un’altra differenza era che i suonatori di Napoli, forse – e rimarco il forse – avevano più professionalità e più sicurezza economica per il mantenimento delle relative famiglia. Mentre da noi, in provincia, più che una prestazione artistica, o una manifestazione di folklore legata ad una lunga tradizione, il gesto era universalmente percepito come forma di raccolta di elemosina: un’occasione per incrementare le entrate che non erano mai sufficienti per chi non aveva altra fonte di reddito.
Questa occupazione, se così vogliamo chiamarla, restava comunque straordinaria e provvisoria, tanto che essa durava lo stretto necessario finché restava la disoccupazione. Specialmente negli anni dell’immediato dopoguerra. La provvisorietà, che si stemperava con l’evoluzione dei tempi, svanì addirittura negli anni del boom economico. Dal 1946 fino a circa il 1960 si trattò di veri complessi canori, richiesti anche nelle ricorrenze e nelle feste di famiglia. Ma a mano a mano che i loro componenti – musicisti o non musicisti – lasciavano l’attività per entrare nel mondo del lavoro normale, le compagnie si riducevano di numero e alla fine restarono solo pochi posteggiatori superstiti, quelli più approssimativi sul versante delle prestazioni “artistiche”. Così, agli inizi degli anni 70, nella nostra cittadina era rimasta una sola coppia, che, senza più “posteggia” (la scelta di posti fissi [‘u posto], da cui il nome), ma in maniera itinerante, chitarra e tamburino, si aggiravano per le strade a chiedere l’elemosina. I loro strumenti non producevano più vere melodie, e si limitavano a ripetere ritmi monotoni, noiose tiritere, percussioni inutili e ridondanti, costanti nella loro circolarità, con qualche variazione di crescendo e una libera voluta sul finale.
“Nicola e Polichetti” – questo il nome del complesso – erano diventati i nostri beniamini, più per simpatia (nel senso originario della parola: compassione) che per il talento, che non c’era mai stato. Finché quelli del nostro gruppo gli diventarono amici. E se Nicola, seppure con qualche dubbio, poteva sembrare il nome del personaggio, Polichetti – pochi sapevano che era un cognome – era ritenuto universalmente il suo soprannome. Comunque il duo canoro, per essere un complesso musicale, aveva acquistato un bel nome d’arte, pur non avendo fatta troppa fatica a sceglierselo, proprio da professionisti. Tuttavia continuava ad esprimersi in un contesto di amicizia.
Alla fine anche Nicola trovò un lavoro, saltuario, a giornate, da muratore. E Polichetti restò solo a svolgere la raccolta delle offerte, continuando girare per la raccolta della questua. Probabilmente cercava di mantenere quel minimo di continuità (il mercato) per far sì che nelle giornate in cui Nicola non era chiamato a lavorare, entrambi, riprendessero senza troppe difficoltà la normale attività da essi abitualmente svolta prima. Mantenevano la piazza, come si dice, cercavano di conservare la clientela: ora che il loro esercizio era avviato, cercavano di reggere il mercato. Ciononostante, non è che le condizioni economiche migliorassero molto. Eppure c’era un aspetto che rivelava la stretta solidarietà dei due, la piena ed equa ripartizione del ricavato, una condivisione senza riserve e senza alcuna clausola contrattuale. Nicola sul cantiere, e Polichetti in giro per le strade col suo tamburo a raccogliere l’elemosina. Che di elemosina si trattasse lo rendeva evidente il fatto che le persone neppure ascoltavano più il ritmo del tamburo, che, orfano della chitarra, era divenuto esclusivamente un vero e proprio richiamo, e rottura … di timpani. Il povero Polichetti faceva quello che poteva. Strimpellava, o meglio percuoteva, al ritmo di marcetta, tambureggiando. E raccoglieva quello che gli offrivano. Ma mentre il guadagno di Nicola in qualche modo era noto, e in un certo senso quantificabile a-priori, anche se era ancora senza busta-paga (e chi t’a ra? A quei tempi, poi!), il ricavato di Polichetti era completamente aleatorio, instabile, incostante, senza nessuna possibilità di previsione. Ciò dava sconforto al povero Polichetti: sconforto anche maggiore per il fatto che si potesse dubitare della sua lealtà, talché lo portava talvolta a rinunciare al suo giro. D’altra parte questo fatto metteva Nicola – non che egli dubitasse dell’onestà dell’amico, più che socio – nella condizione di sospettare che Polichetti rientrasse dalla questua in anticipo, sfiduciato dal modesto raccolto. Allora, d’accordo com’erano sempre stati in tutto, decisero di fare uscire Polichetti col tamburo sui fianchi legato nella vita da una catenella di ottone, fissata con un lucchetto, la cui chiave era custodita da Nicola. Nessuno stupore per le persone che lo incontravano durante il servizio. Molti neppure si accorgevano della novità. Altri pensavano che fosse per avere le mani libere onde governare più comodamente le bacchette che roteavano libere nell’aria, o, anche, per dare stabilità al tamburo.
I due soci continuarono ad essere amici indivisibili, anche se uno aveva famiglia e l’altro era scapolo. Chi non li conosceva personalmente li pensava addirittura cognati, perché solo la presenza di una donna forte, economa, legata dalla sorte a entrambi, poteva più facilmente spiegare la perfetta riuscita di quel sodalizio. La sera, dopo il rientro dell’uno e dell’altro dai rispettivi “lavori”, liberato Polichetti dal tamburo che lo aveva obbligato l’intera giornata, controllato l’incasso, si recavano al bar del dopolavoro, per un caffè o una cioccolata, due chiacchiere e una partita a carte. Non so per quanto tempo durò questo comportamento. Intanto anch’io cominciai a lavorare, e li persi di vista. Ma ricordo che negli ultimi tempi, quando di sera venivano al bar del dopolavoro, a chi gli chiedesse come era andata la questua quel giorno, Polichetti, purché si trattasse di amici e che la domanda non fosse formulata con intenti canzonatori a mo’ di sfottò, rispondeva: “Beh! ‘A musica è leggera, e si fa pesante”.
Luigi Casale
Fonte: www.liberoricercatore.it
e Goffredo Palmerini