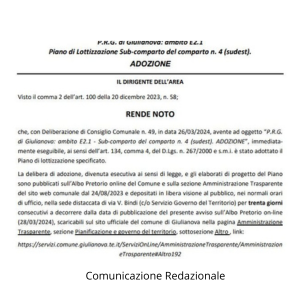Francesca mise la freccia, segnalando che avrebbe girato a destra. Né davanti, né dietro la sua auto, vi era alcuno. Nessuno neanche a piedi. Era tarda domenica pomeriggio. E Francesca entrò, con l’auto, sulla destra, venendo da viale Duca degli Abruzzi, in viale San Giovanni Bosco. Proprio sull’angolo aveva riaperto, forse, il negozio di computer. La serranda a maglie romboidali di ferro, era abbassata. La vetrina, all’interno, chiusa. Francesca non riusciva ad immaginare, qualcuno che arrivasse sin lì per acquistare un computer, o portarlo a riparare. Però, l’insegna era nuova.
Quel negozio, non era lì, prima, ma da un’altra parte, in città; dove avevano appena finito di ristrutturare. Si chiedeva, Francesca, se il trasferimento fosse stato temporaneo, o definitivo; forse i titolari del franchising non potevano più permettersi gli affitti nei locali ora ristrutturati. E comunque, anche se c’era sempre un negozio di computer, lì, non era quello di prima. Ma, immaginava Francesca, i titolari del negozio avrebbero potuto essere gli stessi, di prima, e avevano cambiato semplicemente insegna e azienda, passando da titolari in proprio, ad affittuari di un marchio. C’erano sempre computer lì, all’angolo tra viale Duca degli Abruzzi e viale San Giovanni Bosco, ma, Francesca, non sapeva ricordare il tempo, dal negozio di prima, a quello di oggi. C’era un ricordo, più o meno preciso, e ora, una realtà, non del tutto leggibile, né riconosciuta; ma solo vista, ogni tanto, come si può guardare un muro che scorre dietro il finestrino accanto, mentre si guida. Rifiutata, in una certa misura; rimossa costantemente, ad ogni nuovo sguardo. E, ogni volta, opaca, pur se rimasta negli occhi, volti comunque altrove.
Viale San Giovanni Bosco s’inabissava, in discesa, quasi subito. Giusto il tempo di un veloce sguardo, a sinistra, mentre l’auto camminava lentamente. Verso l’ingresso del Cinema dei Salesiani. Il cancello aperto sul cortile vuoto. Erbacce ovunque. Il palazzotto al fianco dell’ingresso, puntellato, sul lato che dava lungo la strada, da forti travi di legno, ingrigite dal tempo. Come un contrafforte che, con la spalla, sorreggesse la palazzina color giallo dimenticato. Francesca pensò alle sedie di legno del vecchio cinemino. Sul cancello nero, la bacheca destinata ad ospitare il manifesto del film in programmazione, dentro il vetro ingiallito, conservava brani di carta umida e sfatta, biancastra, dissolta. Marcita. Come un sipario chiuso.
Francesca pensò, mentre rallentava ancora l’andatura, a quante volte, era entrata lì, a guardare l’ultimo spettacolo, di film poco visti altrove. Rassegne d’essai. Talvolta pellicole noiose, talaltra, poco più di un pretesto per fumarsi una sigaretta fuori di casa nelle sere d’inverno aquilano freddo. Altre volte, invece, storie delicate, o forti, preziose; come la sensazione di una solitudine che avrebbe potuto incontrare qualcuno, e rompersi, incredibilmente in quel luogo, sulla cima delle scale, per arrivare al cinema, camminando con la mano poggiata sulla ringhiera di ferro, ruvida e tagliente, di ruggine e vernice slabbrata. E guardando in alto, verso il cielo, quasi. I biglietti, ancora quelli antichi, di carta chimica leggerissima, giallina, con sopra stampigliata la parola popolare “Platea”.
Sulla destra, invece, dietro le mura e le inferriate, Francesca sapeva che, in basso, il campo di calcio, non c’era più. Asfaltato. I Salesiani facevano i conti col futuro mercato edilizio. Evitò, per questo, di guardare, alla sua destra in quel tratto, e fermò l’auto sotto gli alberi. In un piccolo slargo. L’ultimo pezzetto di strada, voleva farlo a piedi, anche se stava piovendo; acqua leggera, quasi spruzzata dalle nuvole. Faceva leggermente tremare l’aria, guardandola in controluce, sul fondo del cancello chiuso dell’Istituto delle Suore. Il cancello con le punte di ferro acuminate, in alto. Come se nessuno dovesse entrare, come se nessuno potesse uscire.
Ed ecco aprirsi, sotto i passi di Francesca, piazza della Lauretana. Un quadrato sghembo. Tagliato in diagonale dalla luce del giorno nuvoloso che finiva. Sconnesso e aperto, sui palazzi che soffocavano la chiesetta medievale incastrata dentro l’edificio delle Suore. Che appariva chiuso. Silenzioso. Assente. Indifferente al proprio futuro, deciso dentro sacrestie oscure. Francesca guardava le scritte di spray nero sulle pareti ocra della fabbrica di materassi, indicata nell’insegna dalla parte opposta del vecchio palazzo. Le finestre basse, chiuse con le inferriate.
Francesca si fermò, nella piazza. Ad ascoltare il silenzio, e il sapore dei mattoni ammuffiti, coperti di muschio e alghe verdi, che saliva dai palazzi sventrati più sotto. Era lì, perché aveva bisogno di riordinare le idee. Anche se era difficile, farlo, sotto la pioggia, di una tarda domenica pomeriggio, al confine tra centro storico aquilano e dissennate costruzioni degli anni ’60 del secolo scorso. Anche se era difficile riprendere il filo dei pensieri degli ultimi giorni, piangendo. Piangendo senza farsi notare. In piedi, nella piccola piazza, ma con lo guardo rivolto verso l’angolo più distante, per chi fosse sopravvenuto in auto, scendendo dal viale, diretto verso la deviazione obbligata per via Roma. Che si percorreva solo in discesa, teoricamente, da qualche anno. Con il bavero dell’impermeabile alzato. L’ombrello quasi poggiato sulle spalle, a far da parete tra il suo volto, e chiunque avesse voluto cercarne gli occhi. Che tremavano, lentamente. Lacrime sottili, che stillavano dall’angolo più lontano, a sinistra; restavano ferme, un interminabile pensiero appiccicoso, e poi scendevano, veloci, dallo zigomo verso il bordo esterno delle labbra, come un’arsura da non dissetare.
Francesca aveva presentato il suo lavoro, il lunedì precedente, nello studio dove lavorava. Un grande studio di ingegneri, impegnato nella progettazione di numerosi interventi di ricostruzione. Il suo lavoro, riguardava una soluzione innovativa di salvaguardia di un arco in pietra. Proprio lì, di fronte, all’angolo con via Pretatti, che era diventata un corridoio chiuso, quasi senza luce, per i puntellamenti a destra e sinistra, uniti da un soppalco in legno che faceva da cielo basso e scuro. Ci aveva lavorato con passione Francesca. Per due mesi interi. A toccare quelle pietre con le mani, e a disegnare nel suo stanzino in ufficio i particolari costruttivi, quasi invisibili, che avrebbero dovuto assicurarne la tenuta anche con un futuro terremoto, più distruttivo di quello che ancora pesava spietato, per quelle vie, deserte. Spezzate. Ed ora lo stava guardando, sporgendo un po’ la testa dall’angolo della piazza. In modo da lasciarselo negli occhi, per qualche istante. E immaginando.
L’arco in pietra, e la strada sottostante, sarebbero riemerse bianche, lasciando sulle dita quella leggera polvere di pietra appena lavorata, eppure antica. Come una cipria sottile e profumata. Le pietre avrebbero conservato tutti gli antichi disegni, e nascosto un’anima capace di reagire ai sussulti. Aveva studiato la storia, Francesca, e cercato i materiali nelle cave originarie, badando anche a tenere bassi i costi di lavorazione e posa in opera. E aveva inventato una piccola e solidissima anima metallica, flessibile come l’arco di un cacciatore, capace di stringere a sé ogni singola pietra. Lo immaginava nel sole, il suo arco, Francesca. Lo snodo essenziale per dare il via alla ristrutturazione dell’intero edificio.
Nessuno, le aveva dato quell’incarico. Nello studio. Ma lei si era accorta che, nei progetti affidati ai suoi colleghi, quell’arco restava vuoto. Come se nessuno volesse affrontarlo per primo, ma solo alla fine, quando tutto il resto fosse stato risolto. Ed invece, per lei, doveva avvenire esattamente l’opposto. Quell’arco, trasformato in una colonna agile, capace di tenere su di sé, il peso dei piani superiori. E perciò, in silenzio, aveva sviluppato la sua idea, con l’intenzione di presentarla al suo capo, e la speranza che questo facesse finalmente capire a tutti quanto fosse capace, e brava.
Francesca aveva ancora negli occhi, la riunione di inizio settimana, lo scorso lunedì mattina; tutti i membri dello studio, intorno al grande tavolo delle riunioni. Lei, in seconda fila, senza potersi appoggiare al legno, per prendere appunti. Seduta dritta, alle spalle di tanti suoi colleghi, più esperti, o più diplomatici. O più svelti. I capelli neri, lunghi, raccolti dietro la testa, mentre alcune ciocche le cadevano ai lati degli occhi, ricce, dolci. Gli occhiali dalla montatura nera, sottile. E un’ombra di rossetto rosso sulle labbra. Indossava i suoi jeans preferiti, Francesca, e un paio di Doctor Martin’s nere, basse. Un maglione di cotone un po’ gualcito, largo, che le copriva, parzialmente, i fianchi forse leggermente espansivi.
Il capo parlava di quel palazzo, e di come, ancora, si fosse in ritardo nella progettazione dell’intervento. Seccato. Faceva pesare su tutti le sue parole. Il ritardo, avrebbe anche potuto comportare pesanti penali. Che avrebbero influito sui compensi di ciascuno. Fu allora che Francesca, si alzò dalla sedia. Tutti la guardarono, come se stesse commettendo un atto di grave scortesia. Lei si diresse verso il capo, con le sue carte in mano, e gliele porse. Senza parlare.
Il responsabile dello studio, guardandola, come se la vedesse per la prima volta, prese il suo progetto, indossò gli occhialetti da presbite che teneva nel taschino della giacca, e iniziò ad esaminarlo. Muoveva la testa, ogni tanto, in su ed in giù, come ad assentire. Talvolta alzava lo sguardo, cercando con gli occhi Annarita. Che ricambiava, sorridendo lievemente. Avanzando, sulla sedia, fin quasi ad essere seduta solo sul bordo. Come se attendesse ogni sua parola come una rivelazione indispensabile. E non si curava, nello sporgersi in avanti, di mostrare la sua scollatura, sempre più generosamente. Aveva il seno piccolo, Annarita, ma spavaldo. E lei si guardava intorno, ad ogni sguardo del capo, come a rimarcare che la sua attenzione gli apparteneva. Che nessuno osasse entrare in quel perimetro di cenni sottointesi. Con una smorfia delle labbra, a metà tra un sorriso e i denti che si stringevano, come per un morso. Violento e durissimo. Francesca, vedeva tutto. Era rimasta in piedi, poco discosta dalla poltrona di capotavola, dove sedeva l’ingegnere titolare dello studio, il suo datore di lavoro. Disorientata.
Il suo lavoro, era piaciuto. E, per questo, ne era stato assegnato lo sviluppo ad Annarita. La più capace nel dargli realizzazione pratica, e nell’aggiustare alcuni dettagli che richiedevano duttilità e spregiudicatezza nella conduzione dell’intero progetto. Il capo, aveva sorriso, nell’annunciare che, finalmente, la sua squadra aveva trovato la soluzione per far partire un progetto cui teneva moltissimo, del valore di svariati milioni di euro, e che avrebbe ulteriormente rafforzato il nome dello studio sul mercato. Annarita, dava garanzie di affidabilità, di conoscenza dell’ambiente, di relazioni con i committenti; nessuno meglio di lei, avrebbe potuto condurre a termine quella impresa ambiziosa. Naturalmente sotto la sua costante e attenta supervisione. Sotto la sua mano sapiente e autorevole.
Era stata ringraziata, Francesca, e invitata a riprendere il suo posto a sedere. Nessuno, l’aveva più guardata, nel prosieguo della riunione, che, poi si era sciolta. Mentre tutti circondavano Annarita, congratulandosi con lei per il lavoro che le era stato affidato, Francesca, restava sulla sua sedia, con gli occhi bassi, tentando meccanicamente di rimettere a posto nella sua cartella, carte, disegni, appunti. Matite. Non si era accorta che, improvvisamente, le si era avvicinato, fino a fermarsi a pochissima distanza dalle sue ginocchia, il capo. Che aveva richiesto la sua attenzione, e che, senza guardarla in volto, le aveva detto che avrebbe dovuto parlare con Annarita. Mettersi d’accordo con lei. Francesca ascoltava, senza sentire davvero le sue parole. Si alzò dalla sedia. E uscì dallo studio.
Da quel lunedì, non aveva più rimesso piede nello studio. E, in verità, nessuno l’aveva cercata. Aveva scoperto la propria invisibilità, Francesca. Aveva scoperto quanto era brava. E quanto era inutile. Si sentiva addosso, tutte le tonalità d’ombra da quel lunedì mattino, fino a quella domenica, ormai quasi sera. In piazza della Lauretana.
Era come aver guardato a lungo Gabriele, seduto davanti a lei, a sorseggiare una birra nel pub. Senza aver mai trovato il coraggio di dirgli, con le labbra, quel che gli occhi imploravano. Era come se continuasse a sentire le proprie mani imprigionate nella paura di avvicinarsi a lui. Era la netta percezione di non essere abbastanza. La stessa impossibilità sottile, eppure evidente. Sapere di poter dirigere il proprio lavoro, eppure, nello stesso tempo, avvertire che l’altra, senza avere le sue qualità, era più adatta. Più funzionale, ai disegni del capo. E, sapere, di voler sentire le labbra di Gabriele, piene, calde, sulle sue. Sentirsele nello stomaco. E capire, che lui, mai, l’avrebbe cercata.
Francesca.
Un po’ troppo goffa, nella sua taglia in più, un po’ troppo poco indifferente, per rinunciare tranquillamente alla propria intelligenza e alla propria libertà per essere come il capo l’avrebbe voluta. Riprese la propria automobile. E guidò all’indietro, verso casa, lontano, a Coppito. Passò davanti al ponticello, sul torrente, e guardò alla sua destra, verso l’allevamento di trote. Più in basso, rispetto alla sede stradale.
Francesca pensava alle trote.
Chiuse nelle vasche di pietra, ammassate, le une alle altre. Nutrite sempre della stessa pappa. Senza alghe tra cui nascondersi. Con pochissimo ossigeno da dividere tra tante. Senza nessuna ansa da percorrere. Mura squadrate, brevi, di cemento indifferente. Fino alla rete che le avrebbe afferrate e portate via. Si sentì quasi mancare il respiro. E abbassò i vetri dei finestrini. Guidando così, nel freddo, fino a casa. Forse avrebbero potuto esserci altre direzioni. Altre strade per i suoi disegni.
Era appena entrata, a casa.
Sentì il cellulare che vibrava. Era un messaggio.
Lo lesse.
Era Gabriele.
Aveva preso due pizze, era sotto la sua casa, e le chiedeva se poteva salire.
Colonna sonora: “Other directions” di Nicola Conte