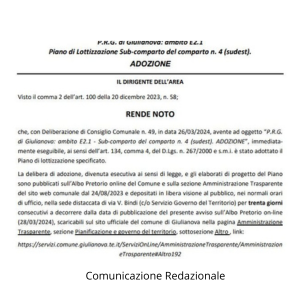di Mario Setta
La Resistenza umanitaria
Un aspetto della Resistenza, rimasto per decenni in ombra o assolutamente ignorato dalla storiografia e dalla memorialistica, è quello dell’aiuto ai prigionieri di guerra alleati in fuga dai campi di concentramento in Italia, dopo l’8 settembre. Un fenomeno che solo negli ultimi tempi è stato evidenziato, attraverso la pubblicazione delle memorie e degli studi di storici inglesi e italiani. Una Resistenza definita da alcuni storici “umanitaria” (De Rosa, Pavone, Pepe, Felice, ecc.), perché fondata sul principio della solidarietà e del rispetto per la dignità della Persona Umana. Un aspetto della Resistenza in cui le donne hanno svolto un ruolo determinante, un aspetto importante di “Resistenza al Femminile”.
Lo storico inglese Eric Hobsbawm, il celebre autore de “Il secolo breve”, ha scritto: “Ho sentito tanti racconti dell’Italia, dai prigionieri di guerra… gente la cui vita era stata spesso salvata dall’aiuto del tutto disinteressato di famiglie di contadini, che non avevano nessuna particolare ragione per soccorrerli se non quella della solidarietà umana”.
Da una ricerca ultra-ventennale, promossa e proseguita da docenti e studenti, presso il Liceo Scientifico Statale “Fermi” di Sulmona, è nata una collana di memorialistica sul fenomeno dell’aiuto ai POWs (Prisoners Of War), durante la seconda guerra mondiale. Roger Absalom, autore d’una accurata indagine dal titolo A Strange Alliance. Aspects of escape and survival in Italy 1943-1945 (Olschki, Firenze 1991), trad. it. L’alleanza inattesa: mondo contadino e prigionieri alleati in fuga in Italia (1943-1945), Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation, ed. Pendragon, Bologna 2011, presentando l’edizione italiana del libro di William Simpson, A Vatican Lifeline. Allied Fugitives aided by the Italian Resistance, (Cooper, London 1995), tradotto e pubblicato con il titolo La guerra in casa 1943-1944. La resistenza umanitaria dall’Abruzzo al Vaticano, scrive: «Il fenomeno dell’assistenza spontanea era generalizzato in tutta la Regione Abruzzese, con punte più alte nelle Province di L’Aquila, Chieti e Pescara. Sulla base di statistiche desumibili dai documenti conservati negli archivi nazionali di Washington, si può calcolare un coinvolgimento di decine di migliaia di persone nell’assistenza, sempre rischiosa, agli ex prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento, dopo l’8 settembre. In rapporto alla popolazione globale delle zone di montagna e di collina, censita nel 1936, la partecipazione si aggirerebbe intorno al 4-5%, cifra tutt’altro che trascurabile, se si pensa che i fuggiaschi alleati di passaggio e di stanza in Abruzzo non erano probabilmente più di 10.000. Altri elementi non quantitativi fanno pensare che la disponibilità a prestare tale assistenza fosse ancora più diffusa». Secondo i dati, rilevati da Absalom, al momento dell’armistizio dell’8 settembre 1943, in Italia vi erano circa 80.000 prigionieri di guerra. L’art. 3 dell’armistizio (short term) recitava testualmente: “Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite dovranno essere consegnati immediatamente al Comandante in Capo alleato e nessuno di essi potrà ora o in qualsiasi momento essere trasferito in Germania”.
Una mappa della Croce Rossa inglese, (The Red Cross and St. John War Organisation, September 1943), evidenziava in Abruzzo la presenza dei seguenti campi: il n.102 a L’Aquila, il n.91 ad Avezzano, il n.78 a Sulmona, il n. 21 a Chieti. Dopo l’8 settembre 1943, si verificò la fuga di migliaia di prigionieri, anche perché il vice-comandante del Campo 78, Rocco Santacroce, favorì l’apertura dei cancelli. Secondo i dati dell’Asc (Allied Screening Commission), sulla base dei documenti rilasciati dagli stessi prigionieri, a Sulmona, nascosti nelle famiglie della città, in particolare al Borgo Pacentrano, furono circa 473. Ma, un dato perlomeno curioso e particolarmente interessante, è rappresentato dalle numerose testimonianze, dirette o indirette, lasciate dagli ex-prigionieri in Abruzzo: Uys Krige, John Esmond Fox, Donald Jones, Jack Goody, John Furman, William Simpson, John Verney, Sam Derry, J P. Gallagher, Dan Kurzman, John Broad, Hans Catz, Tony Davies, Ronald Mann, Guy Weymouth, Joseph Frelinghuysen, John Miller, Martin Schou, Stan Skinner, Gladys Smith. Per questo, il fenomeno dell’aiuto ai prigionieri di guerra è stato definito “epopea”. Una pagina di storia, piena di episodi drammatici e toccanti, comici e romantici: ci furono ex-prigionieri nascosti per mesi nelle grotte, nelle cantine, travestiti da donne, fatti passare per sordomuti e quelli che, dopo la liberazione, contrassero il matrimonio con le figlie dei loro benefattori.
Non è facile restare impassibili di fronte all’avventura di Denys Simmons, raccontata nel documentario 1943 – A Kind of Holiday di Franco Taviani o a quella di William Pusey, le cui figlie sono tornate in Abruzzo, a Castelvecchio Subequo, per spargere le ceneri del padre sulle montagne del Sirente, dove aveva vissuto “il più bel periodo della vita e incontrato l’amore”, come raccontiamo più dettagliatamente alla conclusione. Ma ci furono anche italiani imprigionati, condannati a morte, fucilati per aver dato loro da mangiare e ospitalità. Una forma di resistenza, in cui le donne hanno rivestito un ruolo fondamentale. Valga, per tutte, la storia di Iride Imperoli Colaprete, la staffetta che accompagnava i fuggiaschi da Sulmona a Roma, catturata e imprigionata prima in via Tasso e poi a Civitaquana, con decine di uomini e donne sulmonesi. Una sarta, Annina Santomarrone, di Roio Piano, processata per aver dato ospitalità agli alleati, deportata in Germania e morta in un lager, aveva detto: “Non li ho aiutati perché erano inglesi, ma perché sono una cristiana e anche loro sono cristiani”. Un comportamento, questo, evidenziato anche da un altro fatto tragico: la fucilazione di Michele Del Greco, pastore di Anversa degli Abruzzi, condannato a morte per aver dato da mangiare a numerosi ex-prigionieri, di passaggio. Dalla lettera alla moglie e dalla testimonianza del parroco, don Vittorio D’Orazio, che lo aveva confessato prima della fucilazione, nel carcere di Badia di Sulmona, emerge la stessa motivazione: “Sa perché mi ritrovo in questa situazione? Perché ho fatto quello che mi avete insegnato: dar da mangiare agli affamati”. Era stato arrestato il 22 novembre 1943, processato e condannato il 27 novembre, fucilato il 22 dicembre. Una figlia, Raffaella Del Greco, ne ha raccontato la storia nel libro Quei lunghi trenta giorni (Japadre, 2004).
La gentilezza e la solidarietà degli abruzzesi, al di là della retorica o d’un abusato cliché, emergono dalle innumerevoli testimonianze degli ex-prigionieri che hanno posto in rilievo l’aiuto disinteressato, ricevuto dalla gente. Jack Goody, antropologo di fama mondiale, docente a Cambridge, allora fuggiasco sulle montagne della Valle del Sagittario, ha scritto: “C’era il pane, qualche volta era il pane di campagna fatto di farina e qualche altra era una specie di torta piatta di mais, con in mezzo il grasso di prosciutto” (Oltre i muri. La mia prigionia in Italia, Roma 1997). In una conferenza a Teramo, nel 2002, Jack Goody ha ricordato il suo breve periodo di fuga sulle montagne abruzzesi: «Non ho passato molto tempo in Abruzzo, ma il tempo che vi ho passato è stato molto intenso e mi ha segnato per sempre». Ma, forse, le parole letterariamente più squisite e commoventi sono quelle di Alba De Céspedes, nascosta a Torricella Peligna, in attesa di oltrepassare la linea Gustav, raggiungendo Bari e diventando la voce di Clorinda a Radio-Bari: «Entravamo nelle vostre case timidamente: un fuggiasco, un partigiano, è un oggetto ingombrante, un carico di rischi e di compromissioni. Ma voi neppure accennavate a timore o prudenza: subito le vostre donne asciugavano i nostri panni al fuoco, ci avvolgevano nelle loro coperte, rammendavano le nostre calze logore, gettavano un’altra manata di polenta nel paiolo. […] Del resto attorno al vostro fuoco già parecchie persone sedevano e alcune stavano lì da molti giorni. Erano italiani, per lo più: ma non c’era bisogno di passaporto per entrare in casa vostra, né valevano le leggi per la nazionalità e la razza. C’erano inglesi, romeni, sloveni, polacchi, voi non intendevate il loro linguaggio ma ciò non era necessario; che avessero bisogno di aiuto lo capivate lo stesso. Che cosa non vi dobbiamo, cara gente d’Abruzzo? Ci cedevate i vostri letti migliori, le vesti, gratis, se non avevamo denaro.» (AA.VV., Alba de Céspedes, Mondadori, Milano 2005).
Uys Krige, scrittore sudafricano, prigioniero al Campo 78 di Sulmona, dopo la fuga verso il Sud Italia e il ricongiungimento con gli Alleati, stabilisce rapporti di amicizia con Ignazio Silone, tanto che quest’ultimo, nelle pagine introduttive de L’avventura d’un povero cristiano racconta: « Prima di lasciare Roma e tornarsene nel Sud Africa, nel 1945, Uys Krige mi prese a testimone di due suoi voti: avrebbe scritto un libro su questa contrada che egli chiamava “terra amica e prediletta”, e appena possibile sarebbe tornato portando con sé sua figlia, nella convinzione che avrebbe giovato all’educazione della ragazza conoscere quei posti e quella gente.» L’originale inglese del libro di Krige The way out, tradotto in italiano con il titolo Libertà sulla Maiella (Vallecchi, Firenze 1965) è dedicato ad un contadino di Bagnaturo di Pratola Peligna, Vincenzo Petrella, “to whom I owe my Freedom” (“cui devo la mia Libertà”). La storia delle traversate, dal nord al sud, e in particolare da Sulmona a Casoli, attraverso il Guado di Coccia, rappresenta un momento decisivo nella vita dei fuggiaschi. Era la via più conosciuta e più comune. Ma richiedeva l’assistenza di guide locali. E molte furono le guide sulmonesi che si misero a disposizione per questo compito. Compito rischioso, perché i tedeschi controllavano i valichi di montagna. John Esmond Fox, nel libro Spaghetti and Barbed Wire ( “Spaghetti e filo spinato”, Qualevita 202), ricostruisce con la tecnica del flash-back la sua avventura di prigioniero di guerra prima e poi di fuggitivo tornando perfino da uomo libero in visita al Campo 78 di Fonte D’Amore, nel giugno del 1966. Fox apparteneva al IV reggimento Royal Horse Artillery e viene catturato in Africa dai tedeschi. Trasportato a Napoli con una nave-ospedale, rimane per qualche mese ricoverato nell’ospedale della città. Successivamente viene trasferito a Sulmona e rinchiuso nel campo di concentramento. I suoi vari tentativi di fuga falliscono miseramente, ma dopo il bombardamento alla stazione di Sulmona, il 27 agosto 1943, con due amici, Barrel e Frank, riesce a fuggire. Ospitati da varie famiglie in luoghi sempre diversi, ribattezzati con i nomi in italiano di Paolo Pastore, Francesco Re e Giacomo Volpe, si inseriscono nel piccolo ambiente vicino alla città.
Il 13 gennaio 1944, accompagnati dalla guida Domenico Silvestri, insieme ad un centinaio di fuggitivi, affrontano la traversata della Maiella, arrivando a Palena e poi, dopo trentasei ore di marcia, sono finalmente salvi. Nel Post-Scriptum, Fox scrive: «Del gruppo di cento uomini che si erano messi in marcia, alle quattro di pomeriggio del 13 gennaio, arrivarono a Casoli alle 11 del mattino del 15 gennaio, dopo un cammino di 36 ore, 47 uomini e 22 di essi furono ricoverati in ospedale per congelamento o per spossatezza. Non sono mai stato in grado di sapere che cosa accadde agli altri». Un mese dopo, il 14 febbraio 1944 Fox saluta Domenico e parte per l’Inghilterra. John Verney non ha scritto un libro. Ha scritto una lettera d’amore per i contadini che li avevano sfamati, aiutati, amati. Tre ex prigionieri inglesi. Il titolo del libro, “A Dinner of Herbs” (“Un pranzo di erbe”, Qualevita 2014) desunto da un versetto biblico dei Proverbi (15.17): “Un piatto di erbe con amore è meglio di un bue grasso con odio”, che l’autore pone come epigrafe del libro. La dedica: To Sinibaldo Amatangelo, Antonio Crugnale and their kind (A Sinibaldo Amatangelo, Antonio Crugnale e ai loro familiari) che li avevano aiutati, nascondendoli nelle grotte. Non ha confessato solo i suoi sentimenti, ma ha dimostrato che amare significa conoscere la storia, rivivere l’ambiente, condividere fatiche e speranze. Ha espresso profonda gratitudine per aver imparato, in quei mesi di fame e di rischi, tra grotte di montagna e nascondigli nelle case, che vivere e aiutare gli altri a vivere è l’unico scopo che valga la pena di raggiungere. Una testimonianza straordinaria, quella di Verney. Forse la più coinvolgente e la più bella delle opere scritte dagli ex-prigionieri di guerra in Abruzzo. Artistica nella forma e profonda di contenuto. Solo un innamorato poteva esprimere parole indimenticabili. Verney era ed è rimasto un artista, anche dopo la tragedia della guerra. Quando, più volte, è tornato in Abruzzo, vi è tornato con la voglia di conservare e ravvivare quello spirito di innocenza o, come la chiama, nostalgie de la boue (nostalgia della genuinità), che l’affascinava. «Almost everything in my life that has really mattered goes back somehow to the war. I was about to ad: Goes back to the Abruzzi (Quasi tutto quello che è stato importante per la mia vita lo devo alla guerra. Stavo per aggiungere: all’Abruzzo».
Le donne ebbero un posto di rilievo nella vicenda dell’aiuto ai prigionieri alleati. Purtroppo, subito dopo la guerra, al momento dell’assegnazione dei meriti e delle colpe, il ruolo della donna, che non poteva essere negato, fu minimizzato con l’arma del ridicolo, svilito con insinuazioni offensive. Il maschilismo di cui era fortemente impregnata la società dell’epoca assegnava alla donna due ruoli antitetici: santa o peccatrice. Ruoli, però, sempre secondari e comunque funzionali a quello primario assegnato all’uomo. Questo modello interpretativo ha fatto sì che molte donne, pur impegnate straordinariamente nell’azione umanitaria di soccorso dei prigionieri, temendo di non essere considerate sante, negarono o sminuirono la loro attiva partecipazione. Altre donne, invece, più battagliere e ribelli, che cercarono di far valere i loro giusti meriti, diventarono oggetto di campagne diffamatorie, dalle quali solo pochissime uscirono indenni. L’aiuto che fu dato ai prigionieri non si risolse soltanto nel dare il pane che non c’era, ma si manifestò concretamente e moralmente grazie a quella solidarietà tipica delle famiglie povere di mezzi ma ricche di affetti. È nel calore della famiglia, tra le mura domestiche che si opera la ricostruzione di personalità distrutte da anni di guerra e di prigionia. Trattati nuovamente da esseri umani in una nuova famiglia, i prigionieri rinascono a nuova vita. Ricominciano a sperare e a credere nel loro futuro.
Lo stesso John Furman, nella sua autobiografia Be not Fearful (“Non aver paura”, Garzanti, 1962) pone in rilievo la dedizione, il sacrificio, l’affetto, dimostrati dalle donne sulmonesi: Esterina (vedova Carabia), con il figlio Paolo, che abitava a Sulmona in via Mondello; Maria (Santilli, soprannominata Trippe de Lupe), il cui marito era Cesidio Valeri e il figlio Vincenzo, residenti in vico Breve; Marietta (Petrilli, soprannominata Papung), Ada, Ida, Concetta, Ione, Filomena, Anna, Teresina, ecc. Per tutte, basta l’esempio di Maria (Santilli), che dedica le sue migliori attenzioni ad un malato di eczema, Gilbert Smith. «Ma se mai – scrive Furman – di qualcuno al mondo, si sono potuti travisare la vera indole e il carattere, ingannati dall’aspetto esteriore e dagli atteggiamenti, certo questo avveniva con Maria. In realtà, Maria era un angelo che avrebbe diviso la sua ultima crosta di pane con un cane affamato; assisteva Gil, uno straniero a lei completamente estraneo, in condizioni tali che avrebbero costretto anche molte madri, vinte dal raccapriccio, a distogliere loro malgrado lo sguardo dai figli pur teneramente amati, e gli dedicava tutte le sue cure con una destrezza e un’affettuosità da ispirare un senso profondo di consolante fiducia».
Lola Carabia-Spagnoli, cognata di Gino Ranalli, ricorda ancora quel tempo in cui viveva con la famiglia al Borgo Pacentrano. Nella loro casa era nascosto Albert Duquate, un prigioniero americano, definito da Furman “impulsivo, sempre pronto ad inventar facezie, ex radioannunciatore”. Lola aveva allora venti anni, essendo nata il 16.10.1923. Con la sorella Ivana, che diventerà poi la moglie di Gino, ed altre amiche rischiavano la vita per aiutare i prigionieri. «Un giorno – racconta – sono andata al Comune, dal segretario Ferri, per ritirare una carta di identità falsa per Henri Payonne e l’ho riportata alla famiglia Vecchiarelli, a vico Breve, perché fosse consegnata all’interessato. Dopo qualche tempo venni a sapere dallo stesso Ferri il grave rischio che avevo corso, perché i tedeschi volevano sapere se mi conosceva e lui aveva risposto negativamente, altrimenti mi avrebbero arrestata». Henri Payonne, francese, esponente del movimento di De Gaulle “France Libre” era stato aiutato ad uscire dal campo di concentramento dal barbiere del campo, Vincenzo Pistilli, e nascosto in casa di Roberto Cicerone, soprannominato “Pazzone”, uno dei personaggi più attivi, insieme a Mario Scocco nell’organizzazione per l’ospitalità e l’aiuto ai prigionieri fuggiaschi. Ma anche una simile struttura, assolutamente informale, aveva bisogno di persone che tenevano collegamenti, distribuivano incarichi, realizzavano progetti. Una cerchia di persone direttamente impegnate nello svolgimento di compiti spesso altamente rischiosi. Viene organizzata la fuga di decine di prigionieri ricoverati in ospedale e fatti calare di notte attraverso le finestre, mediante una corda formata da lenzuola annodate. Furono accumulate provviste di generi alimentari, vestiario ed altro materiale da mettere a disposizione dei fuggitivi. Ci furono anche azioni di sabotaggio nei confronti dei tedeschi.
Si stabilirono rapporti affettivi tra ospiti e ospitanti, tra prigionieri stranieri e gente del luogo. Nascondere o “tenere in casa”, come allora si diceva, uno o più prigionieri significava stabilire un dialogo parlato o gestuale. La convivenza nella stessa casa offriva naturalmente l’occasione di conoscersi, allacciare legami di amicizia e di affetto. Furman sottolinea il fattore affettivo esistente in questa condizione di “complicità”. La cortesia e la bontà della gente erano tali che spesso i coniugi cedevano il loro letto matrimoniale per far riposare più comodamente i prigionieri, che venivano rifocillati, rivestiti, aiutati in ogni modo. Gli episodi in merito sono così numerosi che è impossibile enumerarli tutti. Contestualmente all’aiuto dato ai prigionieri, nasce spesso un sentimento più forte, più coinvolgente. È il sentimento dell’amore. E non c’è da meravigliarsi se tra prigionieri, giovani e spesso piacenti, e donne semplici e affettuose sia nato l’amore. Il motto della propaganda fascista Dio stramaledica gli inglesi non sembrava aver sortito nessun effetto. La gente aveva continuato a vedere nell’altro, se disarmato e bisognoso, povero e oppresso, vittima e perseguitato, un possibile amico e non un nemico da eliminare.
Roger Absalom, nella presentazione accurata e approfondita al libro di Simpson in italiano, scrive: «La forma più completa di identificazione tra prigioniero e ospitante avveniva quando l’ex prigioniero si immergeva totalmente nella grande famiglia contadina fino al punto di diventare una specie di parente adottivo. Questo fenomeno si produceva solo nelle condizioni di accoglienza e di rapporti familiari particolarmente idonei, ma non dipendeva necessariamente dalle condizioni materiali propizie: anche dove la cultura contadina era meno omogenea, si riscontrano casi di identificazione in cui la “personalità militare” del prigioniero veniva pressoché dissolta. In tali casi la “pressione psicologica” si spingeva oltre la generica simpatia e il garbato sfruttamento di essa: il prigioniero diventava figlio, fratello, fidanzato “fittizio”, facendo scaturire un processo reciproco di assorbimento e di assimilazione. Dalle fotografie scattate allora e rimaste come patetiche testimonianze nei fascicoli dell’archivio dell’ASC, si vede il prigioniero in mezzo a tutta la famiglia, abbracciato spesso alla “madre”, alla “fidanzata” o al “fratellino”, vestito come gli altri, in un’atmosfera di caldo affetto (sempre dignitoso, però) “famigliare”. A guerra finita, il prigioniero “assimilato” continuava per anni a soffrire un’intensa nostalgia della “famiglia” abbandonata e trovava grigio e insoddisfacente l’ambiente in cui era tornato a vivere. Rievocava in patetiche lettere “i bei tempi… della guerra”, costellati da semplici affetti, innocenti avventure (quasi da boyscout), godimenti materiali intensi, perché effimeri e rubati alla sorte, segnati soprattutto dal sorriso e dal riso, caratteristiche della civiltà contadina, pastorale e carbonara dell’alto Appennino (civiltà della veglia, della novella, del cantastorie, della beffa al potente e allo sciocco) e giustamente indicata da Braudel come incrollabile sostegno della ragione umana in un mondo impazzito. “Rido, dunque sono”: forse è questa la frase braudeliana che contiene l’essenziale spirito della pur pericolosa sopravvivenza, vissuta insieme da contadini e prigionieri».
***
Iride Imperoli-Colaprete
“Donna vibrante di vita e appassionatamente attratta da ogni forma di piacere che l’esistenza poteva offrirle” la descrive John Furman. Nasce a Valmontone, in provincia di Frosinone, il 23.4.1918 da Carlo Imperoli e da Paolina Masciangioli. Il padre muore quando Iride ha pochi mesi. La madre, originaria di Sulmona, sposa in seconde nozze un vedovo con 6 figli, Stefano Marcantonio, dal quale avrà un’altra figlia, Maria. Iride risiede a Sulmona e frequenta la scuola elementare fino alla quinta. Le sarebbe piaciuto continuare gli studi, imparare la musica o studiare canto. Trascorre la sua giovinezza tra Roma e Sulmona. Consegue il diploma di sarta, imparando l’arte alla scuola di Teresa Taglieri-Davini. Va ad insegnare a Rivisondoli. Nel periodo della guerra, abita a Sulmona in via del Borghetto. Finita la guerra, sposerà Ettore Colaprete. Un pomeriggio del settembre ’43, incontra a passeggio nella villa comunale di Sulmona un ufficiale italiano, interprete per conto degli ufficiali inglesi. È presente anche un Generale inglese prigioniero a Villa Orsini che, felicemente sorpreso del fatto che Iride possa andare periodicamente a Roma, le propone di portare un biglietto all’ambasciata inglese presso la Santa Sede. Iride accetta e dopo qualche giorno riceve il biglietto da parte del Generale.
«Voleva addirittura darmi anche l’anello d’oro che portava al dito, ma io rifiutai», aggiunge. A Roma, Iride si reca da Mons. O’Flaherty e gli consegna il biglietto, che aveva prudentemente nascosto in mezzo ad un gomitolo di lana. Le propongono di mettersi a servizio dell’ambasciata per mantenere i contatti con i prigionieri di Sulmona. Iride accetta. Si apre, quindi, un’altra via di fuga, oltre a quella dell’attraversamento delle montagne per raggiungere le linee alleate. Varie volte, tre o quattro, ma tutte rischiose e drammatiche, Iride Imperoli riuscirà ad accompagnare in treno da Sulmona a Roma, a piccoli gruppi, gli ex prigionieri del Campo 78, muniti di documenti falsi, rilasciati dal personale del Comune di Sulmona.
J.P. Gallagher, nel libro La primula rossa del Vaticano, (Mursia, Milano 1967), scrive: «Iride aveva svolto un lavoro magnifico per i fuggiaschi… sembrava capace di riuscire in tutto quel che decideva di fare…». E William Simpson: «Iride si stava comportandosi magnificamente nei nostri confronti e le eravamo profondamente grati.» (La guerra in casa 1943-1944, La resistenza umanitaria dall’Abruzzo al Vaticano, Qualevita, 2004). Absalom ne tenta un profilo psicologico: «Un altro fuggiasco (…) era il capitano William Simpson, uno scozzese che sarebbe diventato l’altro principale agente di Derry nella Rome Organization, e infine il primo capo dell’Asc (Allied Screening Commission). Sia Furman che Simpson presero il primo contatto con Derry tramite Iride, una ragazza di Sulmona la cui personalità e la cui fortunosa carriera a servizio dei fuggiaschi e delle organizzazioni a loro favore si prestano bene ad illustrare l’attrattiva che il coinvolgimento in un tale lavoro aveva per i membri “marginali” della società, abituati ad assumersi dei rischi e generalmente poco rispettosi delle autorità costituite, ma spesso vulnerabili da un punto di vista psicologico: essi cercavano, dal loro improvviso e imprevisto contatto con la guerra clandestina, materiale per le loro fantasie di personale realizzazione, di avanzamento sociale e perfino di redenzione».
Queste, le deduzioni che lo storico Roger Absalom trae dal suo lavoro di ricerca. Al contrario, dall’analisi dell’ambiente, dalla biografia dei personaggi, dal contatto diretto con i protagonisti sopravvissuti, ci sembra di poter desumere che non si è trattato di particolare “attrattiva”, ma di senso di responsabilità, di orgoglio dei poveri che hanno dimostrato, in un particolare momento, la loro dignità. Spesso, invece, non pochi inglesi fecero pesare la loro superiorità. La stessa Iride ricorda che John Furman conservava sempre una certa alterigia da gentleman, dimostrando diffidenza verso gli italiani che trattava spesso con aria di sufficienza. Al di là di una diversità di valutazione, i fatti e le persone che ne furono coinvolte restano fatti e persone reali. L’analisi di un fenomeno così diffuso e comunque collocato entro confini geograficamente ristretti può condurre a due forme estreme di giudizio: l’esaltazione retorica o la riduzione sprezzante. Entrambe da evitarsi. Ed è possibile solo nella misura in cui ci si attiene scrupolosamente alla nuda verità. Nel 2004, a Sulmona, in occasione della presentazione, del libro di William Simpson, in traduzione italiana, lo storico Roger Absalom ha avuto modo di incontrare Iride Imperoli Colaprete e di chiarire molti aspetti di quelle vicende. Un incontro amichevole e commovente tra il grande storico e la straordinaria protagonista. Iride è scomparsa il 9 agosto 2006. Resta, in molte testimonianze di ex-prigionieri, la memoria delle sue gesta.
Maria Di Marzio
Nata a Campo di Giove il 6.12.1906, era una donna di paese, una di quelle donne del passato, che dovevano lavorare come gli uomini per “mandare avanti la casa”, perché i mariti stavano in guerra. Il marito di Maria, Matteo Di Marzio, era stato infatti richiamato. Avevano 4 figli, un maschio e tre femmine. Maria doveva lavorare la campagna, pascolare le pecore, eseguire le incombenze domestiche. Nell’autunno del 1943 incontra i prigionieri fuggiaschi. Racconta: «Venivano dalla montagna e arrivavano alla mia casa, perché si trovava fuori dal paese, in cima al colle. Una volta vennero in sette. Dovetti trovare sette vestiti e dar da mangiare a sette bocche affamate. Li feci sistemare nella soffitta, dove c’era una terrazzina da cui potevano affacciarsi. Gli zaini che portavano li abbiamo nascosti sotto terra. Al mattino portavo loro il latte e si facevano la zuppetta. Stettero a casa quaranta giorni. Eravamo, a volte, una ventina a mangiare, perché arrivarono anche altre persone, che però volevano essere servite e riverite. Mi dicevano di mandar via i prigionieri, ma io rispondevo: “questi non li posso proprio cacciare”. Fu così che una di queste persone va a Sulmona e fa la spia. Il podestà, don Ciccio Puglielli, mi fa dire di allontanare i prigionieri. Mio figlio però li accompagna in una capanna, vicino a Fonte Romana e portavamo loro da mangiare. Arrivano i tedeschi e mi chiedono dove sono i prigionieri. Io rispondo che non so niente. Mi danno tre giorni di tempo per consegnarli. Vengono di nuovo e questa volta mi puntano in petto il fucile dicendomi di parlare e di dire dove sono i prigionieri. Mi dicono che bruceranno la casa e che mi ammazzeranno. Mentre mi tengono ancora il fucile puntato sul petto, rispondo: “ammazzatemi pure, ma io non ho visto nessuno”. La gente che stava vicino si era impaurita. Ma io continuavo a dire di non conoscere nessun prigioniero. Alla fine i tedeschi non spararono e mi lasciarono, andandosene via. Finita la guerra mi hanno dato un premio di quattromila lire. Non so se fosse quella la somma che mi spettava. D’altra parte io non so molte cose. I’ sacce fa’ sole la firme pe’ jì ‘ngalere (io so fare solo la firma per andare in galera)». Maria Di Marzio ha ricevuto un attestato di benemerenza «perché fiera figlia della generosa terra d’Abruzzo durante l’occupazione nazista 1943-1944 con rischio della incolumità personale aiutò, incoraggiò e difese dal tedesco invasore sette ufficiali alleati evasi dal campo di concentramento di Fonte D’Amore». Le è stata inoltre conferita la médaille de la Reconnaissance Française, perché gran parte dei prigionieri salvati erano di nazionalità francese. Alcuni prigionieri sono tornati a rivederla.
La guerra non uccide l’amore
Nell’immediato dopoguerra, si ebbero numerosi matrimoni tra italiane ed ex-prigionieri anglo-americani, aiutati dalle famiglie abruzzesi. Ne riportiamo un caso. Famiglia Salutari, Forca Caruso – Castelvecchio Subequo. Elisabetta Salutari nata il 21.12.1933, racconta: «Nel mese di settembre 1943, mio fratello Giovanni, che era pastore e si trovava a pascolare le pecore, incontra sul monte Ventrino un prigioniero inglese che girovagava da quelle parti. L’inglese gli rivolge la parola e gli fa capire con i gesti che ha fame e vorrebbe un po’ di pane. Mio fratello non aveva niente con sé ma gli dice di venire da noi, suoi parenti, che stavamo in un campo vicino a seminare. La mia famiglia era composta da mio padre Antonio, mia madre e sei figli: cinque femmine e un maschio. Arriva infatti dove stavamo lavorando e lo accogliamo. Mio padre gli fa capire che può restare da noi. Finito il lavoro andiamo a casa, che era una delle Casette di Forca Caruso, dove allora abitavano circa 70-80 persone. Mia madre aveva cucinato le “taccozze”, una specie di tagliatelle senza uova e ci mettiamo tutti a tavola. Il prigioniero mangia e dopo mio padre lo ospita in casa facendolo dormire nel pagliaio. Si chiamava William Pusey. Lo chiamavamo Guglielmo. Dopo qualche giorno che sta con noi, ci dice che ha un amico rimasto nascosto sul monte Ventrino e chiede se può andare a chiamarlo e far venire anche lui. Esce e dopo un po’ di tempo torna a casa accompagnato da un altro prigioniero. Si chiamava L. Jagger. Rimasero parecchi mesi presso di noi. Sapevamo che era proibito tenere in casa gli inglesi. Era pericoloso. Tanto più che i tedeschi passavano spesso sulla strada che congiunge la Marsica con la Valle Subequana e si fermavano a Forca Caruso. Anche tutta la gente delle Casette sapeva che noi aiutavamo gli inglesi, ma nessuno ci ha fatto la spia, svelando ai tedeschi o ad altri italiani che i prigionieri si nascondevano a casa nostra. Jagger era sposato. Rimase con noi fino al mese di marzo del 1944. Poi attraversò le linee e si ricongiunse con l’esercito anglo-americano. William stava con noi e s’era innamorato di mia sorella Iolanda che aveva 17 anni. Era nata il 24.10.1926. La gente un po’ malignava, ma noi ne eravamo contenti. Finita la guerra in Abruzzo e partiti i tedeschi, nel mese di giugno 1944, William, che aveva imparato a parlare italiano, si mise su un balcone e annunciò alla gente di Castelvecchio che era innamorato di Iolanda e che presto l’avrebbe sposata. Infatti il 25 giugno 1944 fu celebrato il matrimonio in chiesa, avendo anche accettato di convertirsi al Cattolicesimo».
Nella parrocchia dei SS. Battista ed Evangelista di Castelvecchio Subequo, sul Registro dei Matrimoni, è conservato l’Atto di Matrimonio, celebrato dal parroco Sac. Paolo De Crescentiis, che conferma quanto narrato da Elisabetta Salutari e che cioè Guglielmo Giorgio Pusey, nato a Hythe Southampton il 10.3.1912, di professione ufficiale dell’esercito britannico, e Iolanda Salutari, figlia di Antonio e Maria Musti, contrassero il matrimonio secondo le disposizioni della Santa Romana Chiesa il 25 giugno 1944. Le pubblicazioni ecclesiastiche erano state eseguite dal 18 al 24 giugno, mentre per quelle civili era stata applicata la norma dell’art. 13 della Istruzione 78 della Sacra Congregazione dei Sacramenti circa l’esecuzione dell’art. 34 del Concordato stipulato l’11 febbraio 1929 tra la S. Sede e il Regno d’ Italia, relativo alla celebrazione del matrimonio agli effetti civili.
«Purtroppo, dopo qualche giorno – continua Elisabetta Salutari nella sua esposizione – William dovette andare a Napoli con altri soldati inglesi. Mia sorella Iolanda dovette restare a casa. La gente le diceva che l’inglese non sarebbe più tornato, ma mia sorella era sicura del contrario. Infatti, dopo qualche mese William torna a Forca Caruso e riparte portando con sé la moglie in Inghilterra. Si sistemarono a Southampton, dove sono vissuti, dando alla luce tre figlie. William era militare di carriera. Una volta fu ospite della regina Elisabetta II. Mia sorella Iolanda è deceduta in Inghilterra nel 1972, dove si trova la sua tomba. Successivamente anche mio cognato William muore, nel 1983. Ma prima di morire esprime quali ultime volontà che il suo corpo sarebbe stato cremato e le ceneri divise: una parte deposte accanto alla tomba della moglie Iolanda, in Inghilterra, e l’altra sparsa nei luoghi di Forca Caruso, dove aveva trovato l’Amore e trascorso il più bel periodo della sua vita.» Le figlie, venute in Italia dopo la morte del padre, hanno esaudito le sue volontà.
Cfr. “Terra di Libertà, storie di uomini e donne nell’Abruzzo della seconda guerra mondiale”, a cura di Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta, ed. Tracce, Fondazione Pescarabruzzo)