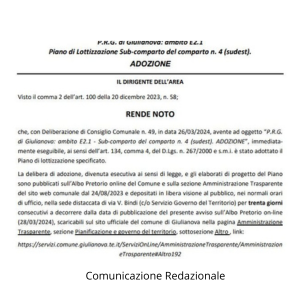Pubblichiamo questo racconto della collega e amica Tonia Orlando.
Erano anni che avvertiva il desiderio di guardare con attenzione storica momenti appartenuti alla sua famiglia e alla fase bellica del secondo Secondo conflitto mondiale. In questi giorni di quarantena, per i noti fatti del Covid-19, nel rileggere quel passato tra il 1943 e 1944, l’autrice fa un percorso di rilettura doloroso nel ricordo dei suoi genitori. Una sorta di “Via Crucis”, mentre gli sfugge la via della verità, sfilacciata e mai conosciuta.
IL VIAGGIO
di Tonia Orlando
Su un autocarro rude e scalcinato, ricoperto da un telo di materiale rigido, sostenuto da sbarre metalliche, se ne stavano in silenzio in una sera uggiosa di metà ottobre del ’43 nella desolata Piazza di Orsogna. Qui erano arrivati con altri due mezzi pesanti della stessa specie adibiti, previo pagamento, al trasporto di merci, armi e persone.
Negli ultimi tempi si viveva così… in fuga.
In paese, da alcune settimane, erano molte le notizie che erano rimbalzate e si erano susseguite in una tensione crescente, in una incertezza dilaniante che alimentavano speranza e angoscia al tempo stesso e nei mesi di ottobre-dicembre dello stesso anno, la nostra gente d’Abruzzo vivrà giornate drammatiche. L’esercito occupante aveva subito una importante sconfitta nella “Battaglia del Sangro” e si era attrezzato a bloccare l’avanzata alleata sulla linea Guardiagrele-Orsogna-Ortona. La risposta era stata quella di una strategia difensiva e la fortificazione del territorio abruzzese attraverso la Linea Gustav, una demarcazione con la quale le truppe tedesche avrebbero resistito agli Alleati Statunitensi e Britannici che procedevano verso Nord, liberando i territori occupati. Grazie alla fortificazione del territorio abruzzese e alla sua naturale conformazione montuosa ne avrebbero rallentata l’avanzata. Il nemico aveva lavorato senza sosta per realizzare la Linea di confine che, dal Fiume Sangro al Garigliano, tagliava a metà l’Italia nella sua parte più stretta. Quelle soldataglie tedesche che prima di allora qualcuno aveva visto in maniera sporadica nei piccoli borghi dell’interno o nei centri maggiori del nostro Abruzzo, ora si insediavano in ogni luogo, terrorizzavano i civili, saccheggiavano, depredavano abitazioni aristocratiche o rubavano nelle già povere case di campagna tutto quello di cui avevano bisogno come cibo, armi, mezzi di trasporto, costringendo le popolazioni del posto a lavorare forzatamente nelle trincee o in lavori di fortificazioni. Successivamente, erano passati alle costrizioni agli sfollamenti di interi paesi; era necessario spingere gli abitanti di quella sciagurata Linea ad abbandonare tutto quello che c’era di più caro come la casa, i beni e permettere che la brutalità bellica inghiottisse ogni cosa. Naturalmente, da parte dei residenti mancava la volontà di fuggire dalle proprie abitazioni e andare via, ma quanti decidevano di non rispettare le regole imposte, sarebbero stati giustiziati in frettolose, crudeli, sommarie fucilazioni. E così, anche la mia famiglia, come tante, si ritrovava sospesa in quella Piazza di Orsogna, nella incosciente speranza di trovare un luogo o qualcuno che l’accogliesse. Ma il pensiero era lì che si attorcigliava, sempre uguale, sempre lo stesso. In tutta fretta, prima di scappare, avevano provveduto a murare nella storica cantina dalle pareti spesse di metà ottocento tutto quello che poteva essere importante come oggetti d’oro, fotografie e quei corredi di lino finissimo della mamma e della zia ricamati a mano, chiusi dentro due cassettoni nascosti dietro altrettante pareti ricostruite con mattoni che i tedeschi, invece, provvederanno a srotolare lungo la strada in discesa, per servirsene e mimetizzarsi, in mezzo alla neve, nei giorni rigidi del ’43/44 ed ingannare gli aerei Alleati in perlustrazione. Ora, da quella Piazza desolata, era appena iniziato il viaggio. Non sarebbe stata Orsogna ad ospitarli, non era sicura, dovevano andare avanti, verso Chieti. All’alba del giorno successivo, il camion li lasciò all’ingresso della città che non subirà alcun danno, alcun bombardamento, perché dichiarata “Aperta”. La città che si offriva ai loro occhi era in un’alba silenziosa ed attonita e come i giorni precedenti avrebbe ospitato quanti si allontanavano dai paesi limitrofi e arrivavano qui, nell’attesa che la Prefettura e le Circoscrizioni ecclesiastiche dessero nuove disposizioni agli aiuti. Quello che invece li attendeva nella città era terrificante. Piazza San Giustino trasformata in un campo di accoglienza. Famiglie intere lasciate in quel largo, in attesa. Furono molti i bambini che in quei giorni morirono di morbillo e di tifo nella disperazione di giovani madri che piansero e urlarono il loro dolore. La mia mamma, all’epoca trentenne, era al terzo mese di gravidanza, aspettava mia sorella, aveva nel grembo la vita, non poteva rimanere in quel luogo di morte. Si racconta che gli abitanti della città di Ortona, insignita della medaglia d’oro al valor civile per aver subito spaventosi bombardamenti aerei e terrestri, all’indomani del Conflitto, rigettassero il pesce in mare ma, mai e poi mai lo avrebbero consegnato ai chietini, per punirli della loro indifferenza. Bisognava rimettersi in viaggio.
Erano molte le informazioni che arrivavano da altri sfollati, di speranza, di disperazione, di paura, di confusione; era necessario capire cosa fare e soprattutto cercare un nuovo mezzo per riprendere il percorso. Mio padre, con l’aiuto dei giovani zii, seppe che c’era qualcuno che li avrebbe potuti accompagnare fino alle porte di Roma e così salivano su un nuovo mezzo con quelle valigie dove avevano messo il poco di cui avevano bisogno ma dove la mamma aveva accuratamente sistemato tutto quello che sarebbe servito per il parto. Ora si viaggiava alla volta della Capitale. Si soffrì molto il freddo in quel mese di ottobre del ’43. Le strade sconnesse e le brinate notturne resero lo spostamento difficile e a tratti disperato. In prossimità di Tivoli la mia famiglia cambiava itinerario; si doveva andare oltre, non era quello il luogo che cercavano. Un altro mezzo li prese alle porte della città che apparve grigia e blindata per accompagnarli in Toscana che da informazioni ricevute li avrebbe accolti. Il giorno successivo, di buonora, erano di nuovo sulla strada; un giovane romano si era prestato ad accompagnarli con una grossa, vecchia automobile a nafta, lenta e rumorosa, con un motore che, ad ogni scoppio, sembrava dovesse stramazzare e non muoversi più. Ci fu un bombardamento appena fuori la città che si lasciavano alle spalle; la loro macchina fece in tempo a buttarsi in una fitta boscaglia ai margini della strada. Fu terribile, una volta ripreso il percorso, vedere un contadino in una pozza di sangue e il suo asino rimasto illeso che ragliava impaurito. Era freddo e buio quando arrivarono alle porte di Anghiari, nei pressi di Arezzo; mio padre aveva un indirizzo scritto sulle pagine di una piccolissima agenda ed era quello di un imponente Convento di monache. Il conducente li lasciò in una piazzetta antistante la Abbazia e qui mia madre suonava la campana per cercare un contatto. Una monaca aprì il pesante portone e li fece entrare; rimarranno in quel luogo per dieci mesi. La mamma avrebbe partorito il 20 aprile del ’44, sarebbe nata mia sorella, regolarmente iscritta nei registri anagrafici del luogo, battezzata a San Sepolcro, circondati da amici che con loro condividevano quell’esilio. “Che bella cittina, proprio bella”, queste le espressioni rivolte alla bimba da quanti ormai li amavano e con i quali vivevano silenzi, bisogni, necessità. Il 25 aprile di quel ’44 l’esercito sovietico e quello statunitense si sarebbero incontrati tagliando la Germania in due; sarebbe stata la fine delle ostilità, sarebbe stata la pace. Prima di allora, i mesi trascorsi in Toscana sarebbero trascorsi distanti dal terrore dei bombardamenti, in un luogo che la Provvidenza aveva fatto incontrare e che i miei non avrebbero mai immaginato esistesse e che potesse prendersi cura delle loro fragili vite. Passò presto quel tempo e la nascita della bambina avrebbe ridato una nuova energia ai genitori e a quanti erano con loro a spartire la speranza. Si arrivò alla fine di giugno e la situazione cominciava a cambiare. Ascoltavano la radio e con difficoltà si apprendevano notizie; seppero di Orsogna, liberata l’8 giugno di quel ’44 dai paracadutisti del Nembo, dopo lo sfondamento della Linea Gustav a Cassino. La stessa Orsogna era in macerie e con lei Ortona, Taranta Peligna, Francavilla al Mare, Roccaraso. E la loro Guardiagrele, la altera “città di pietra”, la generosa “Guardia” collocata di lato alla Majella, che cosa sarebbe stato del loro paese, della loro storia, della loro vita. Il viaggio di ritorno riprese in un torrido mese di agosto. Era la festa dell’Assunta. La mamma si svegliò che pioveva; i giorni passati erano stati torridi e la canicola delle ultime settimane l’aveva fiaccata. Ora la pioggia aveva spazzato l’aria liberandola dei residui di quelle temperature insopportabili. Erano pronti per ripartire. Il primo tratto lo fecero su un grosso carro contadino che li accompagnò fino a Terni dove sarebbero stati caricati da un camion militare di soldati yankee, giovani e forti, che masticavano chewing gum e regalavano tavolette di cioccolato alla mamma e alla bimba. Arrivarono a L’Aquila al tramonto, il tempo di cambiare mezzo e ripartire. Man mano ci si avvicinava al territorio chietino, l’immagine si faceva sempre più drammatica; paesi bombardati, ridotti a brandelli. Incontrarono una giovane madre delirante che alla vista della bimba tra le braccia di mamma, pianse per la sua, di pochi mesi, morta una settimana prima di fame, oppure un soldato che andava recuperando tra le pietre oggetti seppelliti come una forchetta che trovava necessaria in quella disperazione. Fu lì che i miei capirono quanto grave sarebbe stata la situazione che li attendeva. Arrivarono a Bivio Grotte, in prossimità di Guardiagrele; erano molti, tra amici e parenti, a sapere del loro ritorno e li aspettavano in una festa incontenibile. Con la pelle arsa dal sole e una neonata di soli quattro mesi con le spalle e la faccina escoriate, si riunivano agli zii materni che con i nonni erano sfollati nelle campagne di Casoli e ora, tutti insieme, si tornava verso casa. Ma quale casa… la loro era stata bombardata… rimanevano le mura di quella solida, massiccia cantina. Nella foga degli entusiasmi e degli abbracci, si condivideva un dolore profondo in un mare di macerie che non reggeva lo sguardo. Si raccontarono tutto nel pianto e nell’amarezza; qualcuno riferì della mattina del tre dicembre del ’43, quando si pensava fosse vicina la fine della guerra, con i carri armati inglesi arrivati in Contrada Melone, e invece i tedeschi si accanirono trasformando il paese in un inferno di fuoco e di morte. E dello stesso giorno, quando si consumò la tragedia del Piano dove fu bombardato il luogo considerato un rifugio antiaereo, sotto l’antica cisterna dell’acqua; persero la vita dodici persone e successivamente altre tre. Seppero anche che nello stesso giorno, sessantaquattro persone e tra queste il giovane parroco Don Filippo, avevano trovato rifugio in quella loro cantina dalle mura spesse, sotto la casa paterna rimasta senza tetto, insieme con la abitazione di fronte, completamente distrutta; sarà ricostruita a fine anni novanta. E così, si era felici di essere vivi, ma l’anima era dilaniata, annientata, bombardata, sospesa… come lo erano i brandelli di muro.
Tonia Orlando, 25 aprile 2020