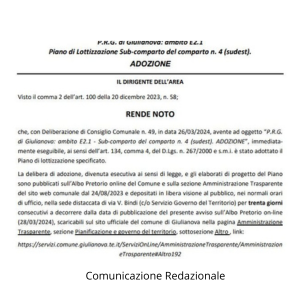Giulianova. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 1 novembre 2005, nella 42° riunione plenaria, con la risoluzione 60/7, stabilì di celebrare ogni 27 gennaio il “Giorno della Memoria”. Fu scelta la data del 27 gennaio perché proprio in quella data l’Armata Rossa entrò per prima nel campo di concentramento di Auschwitz. Pubblichiamo il racconto della prof.ssa Sophie Josephus-Jitta, figlia e testimone diretta della “Giusta” Leonora Josephus Jitta- Leeuwenberg. Recentemente, il 24 novembre 2019, lo Yad Vashem di Gerusalemme, ha dichiarato il riconoscimento postumo della olandese Leonora Josephus Jitta- Leeuwenberg (1905- 1998) come ‘una dei Giusti fra le Nazioni’.
Una vita fuori dagli schemi di Sophie Josephus-Jitta*

Mia madre non fu mai una madre nel senso classico del termine olandese, vale a dire
una mamma tutta casa e famiglia: mia madre lavorava, anche se con qualche intervallo
dovuto alle nascite dei figli. Nel 1929 si era laureata in chimica, dopodiché aveva trovato
lavoro come insegnante, in un liceo cattolico di Alkmaar, una cittadina a nord di Amsterdam.
Questo lavoro le piaceva talmente tanto che continuò a farlo anche dopo aver raggiunto
l’età della pensione, non più a tempo pieno però, come prima della guerra, ma a metà
tempo o meno ancora e dopo la pensione in una scuola serale per laboratoristi.
Il pomeriggio, quando noi figli tornavamo da scuola (abitavamo a Heiloo, un paesino a 4
chilometri di bicicletta da Alkmaar), diversamente dalle tradizionali madri olandesi, la
mamma non ci aspettava con il té e i biscotti e non era tutt’ orecchi per le nostre avventure
scolastiche. Lei si trovava nel proprio studiolo a preparare le sue lezioni o a correggere
compiti. Se il fatto di non essere accolti a braccia aperte dalla mamma da noi figli era
accettato – anche se non sempre gradito – dal mondo esterno invece era considerato come
particolare. Infatti, nella società olandese degli anni ’50- mia madre aveva ripreso a lavorare
nel 1948- lavorare fuori casa era considerato poco dignitoso per una donna sposata. C’era
addirittura una norma per cui una donna sposata (specie se cattolica) doveva cedere il posto
che occupava se questo era richiesto da un uomo. L’idea era che gli uomini avevano bisogno
di lavorare per poter mantenere la famiglia, mentre per le donne lavorare era
semplicemente un lusso. La mia mamma però era fermamente dell’opinione che la regola
era un’idiozia che non la riguardava. Così, quando effettivamente si verificò questa
situazione lei tenne duro e non lasciò la scuola. Ostentamente continuò a far lezione e
altrettanto ostentamente presenziò alle riunioni degli insegnanti, perché voleva dire la sua e
non ammetteva che si parlasse di lei e della sua posizione alle sue spalle. Si mormorò e si
gridacchiò allo scandalo; solo quando aveva ‘vinto’ – il collega si era ritirato – mia madre
presentò le sue dimissioni: non voleva più lavorare in quella scuola. Qualche tempo dopo
trovò lavoro in un altro liceo.
L’azione di soccorso clandestina
Nel maggio del 1940 i tedeschi occuparono l’Olanda e nel 1942 emanarono le prime
vere e proprie leggi razziali. Ai bambini ebrei, ad esempio, non era più permesso frequentare
una scuola ‘normale’; dovevano frequentare una scuola esclusivamente per ragazzi ebrei. Ad
Amsterdam, con la sua popolazione di 70 mila ebrei si istituì un ghetto. In tutto il paese poi
gli ebrei furono costretti a portare la stella gialla, appena uscivano di casa e poco dopo
dovettero lasciare il posto di lavoro. Mio padre, che era laureato in legge e faceva il
banchiere e il giudice supplente presso il tribunale di Alkmaar, era già stato licenziato nel
1941, perché per le forze occupanti tedesche era ebreo. Il suo essere cattolico non contava.
Poco più tardi alcuni suoi amici gli consigliarono di divorziare: anche se le persecuzioni
razziali non erano ancora cominciate, la situazione degli ebrei non poteva che peggiorare.
Poi, anche se il matrimonio dei miei era un matrimonio misto e gli ebrei nelle unioni miste
per il momento venivano lasciati in pace, in futuro sarebbe toccato sicuramente anche a
loro. Inoltre, per mia madre, con tre figli in tenera età che secondo la terminologia nazista di
allora erano dei mezzi ebrei e che come tali prima o poi sarebbero stati soggetti a delle
misure restrittive, sarebbe senz’altro stato meglio non avere più un marito ebreo.
I miei nel mese di marzo del 1942 effettivamente divorziarono. Mio padre andò ad
abitare ad Amsterdam, presso un’anziana vedova ebrea affittacamere, ma continuava a
vedersi con mia madre ed i figlioletti. Nell’autunno dello stesso anno però la situazione
cambiò. Ebbero inizio i primi rastrellamenti e il mio papà, con i suoi tratti somatici così
chiaramente ebraici, avrebbe corso un grosso rischio uscendo di casa. Ma egli usciva
ugualmente e andava a . . . guardare come i tedeschi catturavano gli ebrei, convinto com’
era di non correre nessun pericolo essendo di estrazione sociale ‘alta’. Discendeva da una
famiglia di mercanti internazionali di oggetti d’arte e gioielli ‘benissimostante’ che dopo il
1880 si era trasformata in una famiglia di professionisti e intellettuali. La signora
affittacamere fece sapere alla mia mamma che il comportamento del mio papà era troppo
pericoloso, non solo per sé stesso ma anche per lei e gli altri ebrei a cui affittava una stanza.
E papà fece ritorno a Heiloo. Per più di due anni sarebbe rimasto nascosto nella propria
camera da letto. La casa era grande e si trovava in una posizione strategica, proprio ai
margini di un bosco. Nei primi mesi della guerra mia madre aveva fatto costruire un
nascondiglio, al primo piano, nella propria camera da letto, dietro il letto matrimoniale.
L’aveva fatto fare abbastanza grande di modo che – in casi di emergenza – lì si potessero
nascondere più persone.

Già alla fine del 1942 – con le persecuzioni razziali appena cominciate – la mia mamma
ospitava nelle camere da letto del primo piano oltre all’ex marito altri 5 ebrei: una signora
che si era ‘autoofferta’ come domestica, perché aveva bisogno di soldi e le era permesso di
lavorare soltanto in casa di ebrei. Sarebbe rimasta tre mesi. Poi c’era una bambina di 5 anni
portata dal fratello di mia madre, uno dei medici della resistenza di Alkmaar. Per la bambina
ben presto si cercò un’altra sistemazione: moriva di nostalgia. Non poteva né telefonare ai
suoi né ricevere lettere da loro. Doveva sempre stare chiusa in camera, una camera poi che
divideva con degli adulti completamente sconosciuti. Era troppo pericoloso farla uscire giù o
in giardino a giocare con i miei fratellini, che dovevano assolutamente restare all’oscuro di
quanto succedeva in casa.

In più c’era il figlio tredicenne della sorella di mio padre, il quale non poteva più
rimanere ad Amsterdam, dove i rastrellamenti di ebrei erano all’ordine del giorno. Rimase
mezz’anno a Heiloo per poi andare a nascondersi da una famiglia di contadini in Frisia, nel
lontano nord del Paese. Mi permetto una piccola divagazione: questo mio cugino era basso e
biondo e aveva gli occhi chiari. Nessuno lo prendeva per ebreo e perciò godeva di qualche
libertà nel paesino dove abitava. S’impadronì del dialetto locale, diede una mano al
contadino che lo ospitava e imparò a mungere le mucche: conseguì addirittura il diploma
ufficiale di ‘mungitore di mucche’. Molto più tardi, quando ormai era professore di
fitopatologia alla Facoltà di scienze agrarie di Wageningen raccontava spesso ai suoi studenti
di avere il diploma di mungitore di mucche e di essere uno dei due professori con questa
qualifica (l’altro era figlio di contadini).
Poi mia madre ospitava una giovane coppia sposata, Carrie e Hugo E., che mio padre
aveva conosciuto ad Amsterdam, dalla signora affittacamere. A un certo momento la coppia
dovette cercarsi un altro alloggio. ‘Da me c’è posto’ disse mia madre. Carrie e Hugo rimasero
alcuni mesi. Il maresciallo dei ‘carabinieri’ di Heiloo (paesino dove tutti si conoscevano e
dove certamente a molti non era sfuggito che in casa Jitta si era in più delle 4 persone
ufficialmente registratevi) telefonò a mia madre per dirle che aveva ricevuto l’ordine di farle
una piccola visita, lo stesso pomeriggio. Mia madre captò il messaggio e mandò la coppia e
mio padre a fare una lunga passeggiata nel bosco. Dopo il concordato segnale di ’tutto a
posto’ rientrarono a casa.
Nell’autunno del 1943 mia madre ricevette una telefonata da un amico notaio: egli
teneva nascosto una coppia di coniugi ebrei, ma per certi motivi non era più in grado di
ospitarli. La scelta per loro, così disse il notaio, era o cercare un altro posto o prendere del
veleno (la modalità di suicidio scelta da alcuni ebrei poco prima o poco dopo l’occupazione
nazista). ‘Fateli venire da me’ propose senza esitazione la mia mamma. I due si fermarono da
lei tre, quattro mesi. Non andavano molto d’accordo con l’altra coppia però e Carrie e Hugo
a un certo punto trovarono un’altra sistemazione. Fino al 1996 mia madre non avrebbe più
avuto notizie da loro.
All’inizio del 1944 arrivò un’altra chiamata urgente, questa volta da un gruppo di
studenti dell’università di Amsterdam, che s’impegnava a trovare dei nascondigli per ebrei.
Una giovane signora dai lineamenti molto ebraici aveva immediato bisogno di lasciare
Amsterdam. Il giorno prima i tedeschi avevano catturato il marito, mentre lei era riuscita a
scappare, con il figlioletto di un anno. Per il piccolo era già stato trovato alloggio, ma per la
signora ancora no. ‘Mandatela da me’ fu la reazione della mia mamma, ‘a me non interessa il
fisico della signora; del resto so cosa vuol dire ‘visibilmente ebreo’. Io ormai sono abituata ai
cosiddetti ebrei classici’.
La signora andò a Heiloo, munita di una falsa carta d’identità e con il nome di Bets (un
nome molto più ‘ariano’ del suo). Con sua grande soddisfazione trovò una famiglia con tre
piccoli bambini; siccome sentiva tanto la mancanza del suo Samuelino si affezionò loro
moltissimo. Aiutava mia madre – che non aveva più né la domestica né la bambinaia – ma per
motivi di sicurezza il suo territorio doveva rimanere ristretto: al solo primo piano. Fino al
momento della liberazione (maggio 1945) mia madre le diede una paga da bambinaia. ‘Se tu
lavori per me, è giusto che io ti paghi’, fu il ragionamento di mia madre. Probabilmente fu
l’unica in tutta l’Olanda a pagare un’ebrea nascosta. Di solito la situazione era rovesciata:
erano gli ebrei che dovevano pagare fior di quattrini a chi si era dichiarato disposto a
ospitarli. La maggior parte degli ebrei olandesi era povera in canna però e non era in grado di
pagare nulla. Del resto, gli olandesi disposti a salvare la vita altrui furono pochi: o non
avevano la disponibilità materiale (casa troppo piccola) o non avevano il coraggio (chi veniva
colto dai tedeschi finiva anch’egli male) o non volevano aiutare un ebreo. Difatti,
dall’olandese medio gli ebrei erano visti come degli imbroglioni nati. Ancora oggi c’è chi dice
‘quando dai la mano a un ebreo dopo è meglio che ti conti le dita’. Gli olandesi, che
godevano – e godono tuttora – fama di essere tolleranti non fecero praticamente nulla,
quando i tedeschi presero a deportare gli ebrei. Un tale atteggiamento in fin dei conti si
spiega: la famosa tolleranza olandese è sempre stata basata sul lucro, sul vantaggio
economico che i ‘tollerati’ potrebbero portare. Ormai però gli ebrei non valevano più nulla,
sia perché erano nati e cresciuti poveri sia perché non potendo più svolgere nessun lavoro i
loro mezzi erano limitati. Ecco perché gli olandesi in generale non mossero un dito. Con
risultati tristissimi poi: dei circa 140 mila ebrei di prima della guerra ne furono ammazzati nei
lager 104.000; dai campi ne tornarono poco più di 5 mila e 10.000 sopravvissero grazie a
figure come mia madre o in qualche altro modo. Sì, lo so, mia madre aveva la possibilità sia
economica sia logistica di ospitare degli ebrei, ma non tutti quelli che avrebbero potuto farlo
aiutarono effettivamente gli ebrei: ci voleva una stoffa ben speciale.
Nell’autunno del 1944 fu imposto a mia madre di evacuare la casa; i tedeschi erano
convinti che tra poco sarebbero sbarcati gli alleati – Heiloo dista dal mare circa 8 chilometri –
e la villa faceva loro gola. Si presentarono però due piccoli problemi: bisognava demolire il
nascondiglio dietro il letto (i tedeschi l’avrebbero indubbiamente scoperto e avrebbero
intuito quale ne era stata la funzione, con il conseguenti arresto e uccisione di mia madre) e
come si faceva ad evacuare anche quelli che ufficialmente non c’erano? Il nascondiglio fu
abbattuto e per mio padre e la signora Bets si trovò la seguente soluzione: la nuova casa era
a Haarlem, una cittadina nei pressi di Amsterdam, e per arrivarci Bets avrebbe preso il treno.
Ovviamente doveva mimetizzarsi. Si vestì da domestica, con tanto di secchio e scopa e con
gli zoccoli ai piedi e salì sul treno. Fu tanto disperata quanto coraggiosa: i treni pullulavano di
soldati tedeschi e molti altri nei suoi panni avrebbero preferito suicidarsi. Lo stratagemma
riuscì: Bets arrivò a destinazione sana e salva.
Il problema per il trasporto del mio papà era più grande: egli era goffo e ingenuo e si
sarebbe facilmente tradito. La mamma ebbe un lampo: vestiamolo da traslocatore, con una
bella tuta blu e un bel berretto e facciamolo andare a Haarlem con il camion dei traslochi. Il
camionista intuì però che quella figura sconosciuta non era uno del mestiere e capì anche
che razza di uomo era. Qualche tempo dopo, nell’inverno del 1944/-45 – che sarebbe stato
lungo e durissimo e per questo chiamato hongerwinter, inverno della fame, – egli bussò alla
porta della nuova casa di mia madre e pretese da lei del cibo. Se non gliel’avesse dato egli
l’avrebbe denunciata ai tedeschi per aver in casa un ebreo (che intanto in quella piccola casa
di nascosti ce ne fossero ben quattro – la resistenza di Haarlem vi aveva sistemato altri due
ebrei- il camionista non lo sapeva). La mamma non si spaventò e non gli diede nulla: gli
indicò la porta. Qualche giorno dopo l’uomo mandò la figlioletta a chiedere la stessa cosa,
armata di un bigliettino che diceva chiaro e tondo che egli sapeva delle attività di mia madre
e che non avrebbe esitato a tradirla se non gli avesse dato della roba da mangiare. Mia
madre fece di nuovo ‘il gran rifiuto’, ma fece anche un’altra cosa. Telefonò a un amico
partigiano e lo pregò di prendere a bastonate quell’uomo, cosa che, con sua grande
soddisfazione, puntualmente venne fatta. Lei a me ha sempre detto: ‘se l’autista del camion
avesse chiesto del cibo senza farmi delle minacce gli avrei dato qualcosa, ma a chi mi
minaccia non do assolutamente nulla’. E sapere che durante quel terribile inverno le mamme
nella parte nordoccidentale dell’Olanda (il Sud e le isole del sudovest erano già stati liberati)
intraprendevano dei lunghissimi viaggi in bicicletta, una bicicletta senza gomme, in cerca di
patate, bietole o addirittura bulbi di tulipani. Bussavano alle porte dei contadini che in
cambio di cibo volevano soldi e oggetti utili, quali asciugamani, materassi o corredini per
neonati. Le mamme avevano già all’andata la bicicletta stracarica, figurarsi al ritorno. Spesso
si trattava di percorsi di decine e decine di chilometri, con un vento forte e gelido e sempre
contrario. Gli uomini non facevano questi ‘hongertochten’, itinerari della fame: o lavoravano
ancora o si nascondevano dai tedeschi, non avendo ubbidito all’ordine di andare a lavorare
in Germania.
Dopo la liberazione
Il 5 maggio del 1945 l’Olanda fu liberata e mia madre potè tornare a casa, a Heiloo.
Bets andò in cerca del figlioletto e del marito; ritrovò il suo Samuelino ma non il marito:
questi era stato deportato in Germania ed era conseguentemente ucciso in un campo di
sterminio, come del resto quasi tutti i parenti, sia di lei sia di lui. Anche il mio papà non
dovette più nascondersi e ‘tornò a galla’, come si suol dire in olandese. Il risultato fui io:
nacqui esattamente 9 mesi dopo la liberazione. Per il semplice fatto di essere in viaggio
avevo cagionato quello che si potrebbe chiamare il matrimonio riparatore dei miei genitori:
essendo da tempo divorziati se non volevano che il nascituro diventasse figlio naturale
dovevano al più presto risposarsi (l’uno con l’altra).
Se quando io ero piccola a casa mia si parlava poco delle angherie della guerra, con il
passare degli anni e più precisamente dopo la morte del mio papà (1984) la mia mamma
prese a parlarne volentieri. Raccontava quanto fosse successo durante la guerra con grande
disinvoltura, minimizzando il suo ruolo nel salvataggio di vite ebraiche. ‘Ho semplicemente
fatto il mio dovere’, diceva. Le urtava però moltissimo il fatto che Carrie e Hugo non si erano
più fatti vivi con lei. Anche se sapeva che erano stati ‘salvati’ – la mia nonna materna aveva
tenuto nascosto i genitori di Carrie – non capiva il loro silenzio postbellico. Nel gennaio del
’96 al mio occhio saltò un annuncio sul giornale: era morta a Nuova York una certa Sarah E.,
amata sorella/ cognata di Hugo e Carrie E., di Haifa, Israele. Quindici giorni dopo scrissi loro
una lettera, essendo fermamente convinta di aver ritrovato i due ‘dispersi’ di mia madre. Ed
infatti! Hugo mi telefonò, un po’ timido, benché ormai avesse ottant’anni, e anche un po’
vergognandosi per non essersi mai più fatto vivo con mia madre. Lui e la moglie erano
emigrati in Israele negli anni 60, ma tornavano spesso in Olanda. Telefonò anche a mia
madre – la quale era del resto già stata avvertita da me. La telefonata le piacque
immensamente, così come le piacquero le conseguenti visite della coppia. Al primo incontro
io fui presente, per calmare le eventuali acque mosse. Temevo che mia madre, aprendo la
porta, dicesse come minimo ‘Di già?’. Tutto andò perfettamente liscio invece: io rimasi
piacevolmente sorpresa nel vedere due ottantenni e una novantenne che non si vedevano
da 53 anni riprendere il discorso dove nel 1942/43 lo avevano lasciato. Dopo quel primo
incontro, i tre risaldarono i vecchi rapporti: si telefonavano, da Haifa arrivavano dei regali e
quando la coppia si trovava in Olanda non mancò di far visita a mia madre. E se lei in cuor
suo serbava una puntina di rancore nei loro confronti, non glielo disse mai. Lo disse solo a
me.
Nel 1998 il medico le diagnosticò un cancro senza speranza di guarigione. La mia
mamma affrontò la propria immanentissima fine con lo stoicismo di sempre: telefonò ad
alcune persone per prendere commiato da loro (e non viceversa), preparò la ceremonia della
sua cremazione e aspettò che giungesse la sua ora. Tenne in mano la regia fino alla fine.
Il riconoscimento postumo
Nel 1996, quando Carrie e Hugo si precipitarono a Heiloo, proposero a mia madre di
avviare la pratica per il suo riconoscimento come ‘una dei Giusti’, ma lei reagì dicendo chiaro
e tondo ‘No, non se ne parla nemmeno. Ho fatto solo il mio dovere’. Nel 2018 però, venti
anni dopo il suo decesso, per motivi in questa sede irrilevanti, decisi io di fare un tentativo,
nonostante quel reciso diniego. Dopo uno scambio di e-mail con la sede di Yad Vashem
Gerusalemme e dopo aver inviato l’abbondante documentazione riuscii a farla riconoscere
come una ‘Giusta’: una persona non ebrea che salvò la vita a un ebreo durante la seconda
guerra mondiale. In realtà Leonora Josephus Jitta- Leeuwenberg salvò la vita a sette ebrei.
L’alloggio segreto da lei offerto agli altri sei ebrei tra il 1942 e il 1943 era durato al massimo
un paio di mesi e risultò non rientrante nella vera e propria, ristrettissima categoria dei
‘salvavita’.
Sophie Josephus-Jitta